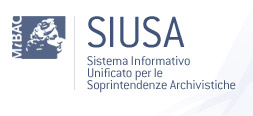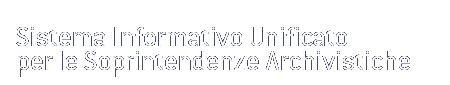Date di esistenza: sec. XII fine -
Intestazioni:
Comune di Volterra, Volterra (Pisa), sec. XII -, SIUSA
Altre denominazioni:
Comunità di Volterra, sec. XII - 1808
Mairie di Volterra, 1808 - 1814
Comunità di Volterra, 1814 - 1865
Comune di Volterra, 1865 -
A Volterra, durante l'età carolingia, la debolezza dell'istituzione comitale avvantaggiò i vescovi, che ricevettero dai sovrani una corposa serie di privilegi e che successivamente, con gli Svevi, si videro di fatto riconoscere l'esercizio di prerogative di tenore comitale e il governo della città con il diritto di eleggere in autonomia i consoli e di battere moneta; tale regime rappresentò un freno allo sviluppo del Comune, un’istituzione che altrove, in Toscana, era invece espressione di maggiore libertà e autonomia per la popolazione. Tuttavia, a partire dalla fine del XII secolo si fecero largo a Volterra istanze di autonomia da parte della comunità cittadina, nell'ambito della quale si affermarono personalità la cui ascesa sociale non era inquadrata dal potere vescovile: il simbolo di questo cambiamento fu la costruzione (1208) del Palazzo dei Priori, situato nella piazza principale di Volterra che prefigurò il declino del potere dei vescovi nell'agone urbano (rimanendo ancora forte, però, nelle campagne). Contestualmente, il Comune cittadino cercò di consolidare il proprio dominio sulle zone circostanti creando, oltre al contado (che comprendeva i territori prossimi al capoluogo), anche un distretto (di cui facevano parte i castelli più lontani).
Nel XIV secolo i contrasti per il controllo della carica vescovile provocarono duri scontri all'interno della città: nel 1340 la famiglia dei Belforti ebbe il sopravvento riuscendo a espellere da Volterra i rivali Allegretti; da quel momento la città fu controllata da una signoria familiare.
Le cose cambiarono di nuovo di segno nel 1361, quando il principale esponente dei Belforti fu giustiziato e la famiglia cacciata da Volterra. Di questi contrasti approfittò il Comune di Firenze, il quale, attirato anche da prospettive economiche in ambito minerario ed estrattivo e ponendosi come mediatore fra le parti, si assicurò il controllo delle istituzioni urbane volterrane. Firenze riconobbe l'indipendenza di Volterra ma solo formalmente: in realtà, il Capitano del popolo, cioè il più importante magistrato della città, era scelto dalla Dominante che nel 1427 arrivò anche a imporre a Volterra l'applicazione del Catasto. I tentativi di rivendicare degli spazi d'autonomia da parte dei Volterrani furono definitivamente stroncati nel 1472 quando, all'indomani del famoso "sacco di Volterra", la città perse ogni residua forma di autogoverno.
Oltre che come centro di potere autonomo e teatro dell'operato di istituzioni locali, Volterra ebbe particolare rilievo anche come sede di istituzioni designate dall'esterno - in particolare da Firenze - e lì residenti con competenza territoriale estesa al territorio circostante, ampliatosi e contrattosi nel tempo ma sempre ritenuto strategico e importante soprattutto per il fatto di trovarsi in una zona di confine ed estremamente interessante dal punto di vista economico. Ciò è vero in particolare per l'amministrazione della giustizia, attività per la quale i giusdicenti residenti a Volterra hanno prodotto quella cospicua documentazione che oggi costituisce il nucleo più importante dell'archivio storico cittadino. Fino al 1472, infatti, Volterra era sede di un podestà con competenze civili e criminali: il podestà esercitava un grosso controllo giurisdizionale anche sul contado, nominando gli ufficiali di Pomarance, Castelnuovo, Monteverdi, Montecatini, nonché il podestà della montagna volterrana che si occupava, con l’aiuto di cinque notai scelti fra cittadini volterrani, dei comuni di Querceto, Gello, Sassa, Montegemoli, Micciano, Libbiano, Lustignano, Serrazzano, S. Dalmazio, Montecerboli, Sasso, Leccia, Castelvolterrano e Mazzolla. Con il sacco fiorentino, compiuto nel giugno del 1472, Volterra perse completamente il controllo giurisdizionale sul contado. L’istituzione del vicariato di Val di Cecina, con sede, prima, alternata tra Pomarance e Castelnuovo e, poi, definitiva a Pomarance, avvenuta nel luglio seguente, significò per Volterra perdere le proprie competenze civili e criminali su un vasto territorio, che si estendeva sulla riva sinistra e destra del fiume Cecina fino ai confini con lo stato senese, parzialmente segnati dal fiume Cornia. Con la sottomissione a Firenze fu stabilito anche che il capitano, con poteri civili e criminali, dovesse essere un ufficiale fiorentino: le sue sentenze criminali erano inappellabili, mentre per quelle civili il tribunale d’appello era rappresentato dalla Corte del Capitano della città di Firenze. La nuova organizzazione data al territorio volterrano all’indomani del sacco non ebbe, però, carattere stabile. Il 5 ottobre del 1513, infatti, per premiare la fedeltà di Volterra a Firenze, il vicariato di Val di Cecina fu soppresso ed i territori in esso compresi furono assegnati nuovamente a Volterra, che riacquistò la facoltà di inviarvi propri rettori di giustizia, come avveniva anteriormente al 1472. Tali rettori giudicavano le cause civili inferiori alle venticinque lire; contro le loro sentenze era ammesso unicamente l’appello davanti al podestà di Volterra. La balìa del 5 ottobre 1513, inoltre, restituì, a Volterra gran parte degli antichi privilegi: venne ripristinato il tribunale dei priori e fu nuovamente istituita la carica del podestà, che era stata soppressa nel 1472 a seguito del sacco; fu però stabilito che la sua nomina fosse di competenza fiorentina. Il podestà tornò ad avere competenze civili, mentre al capitano rimasero quelle criminali; la giurisdizione del danno dato passò ad un apposito ufficiale. Il 19 gennaio 1528 l’ultima repubblica fiorentina, allo scopo di colpire Volterra rimasta fedele al partito mediceo, soppresse la carica del podestà, riaffidando tutti i poteri giudiziari al capitano e istituendo di nuovo nel contado, anche se per un breve periodo (1528-1530), il vicariato di Val di Cecina, con gli stessi poteri che aveva avuto fino all’ottobre del 1513. Volterra perse, così, nuovamente il diritto di eleggere ed inviare giusdicenti nel contado. Al ritorno dei Medici, il 10 dicembre 1530, il vicariato di Val di Cecina fu soppresso per la seconda volta, ma non fu ripristinata la podesteria di Volterra; tutti i poteri furono attribuiti al capitano di Volterra, il quale, data la difficile situazione dell’ordine pubblico nella fascia meridionale dello Stato, fu anche nominato commissario con il compito di affiancare nel penale il capitano di Campiglia e di Gherardesca e di svolgere il ruolo di polizia confinaria. La provvisione del 3 giugno 1531 eliminò il capitanato di Campiglia tra le competenze del capitano di Volterra, al quale furono nuovamente attribuite competenze criminali, civili e sul danno dato. Nel contado integravano l’attività del capitano sette ufficiali: quello di Castelnuovo, quello di Montecastelli, che serviva anche Silano, quello di Pomarance, con competenza anche su Montecerboli e S. Dalmazio, quello di Monteverdi, che serviva anche Canneto, quello di Querceto, con competenze anche su Sassa, Micciano, Libbiano e Montegemoli, quello del Sasso, che serviva anche Serrazzano, Leccia e Lustignano e quello di Montecatini, con competenza anche su Gello. Dei sette ufficiali del contado, due, quello di Castelnuovo e quello di Montecastelli, venivano nominati localmente, gli altri erano inviati dal capitano di Volterra, che li doveva scegliere tra i notai abili di questa città.
La legge del 13 febbraio 1546 ridimensionò il numero dei componenti la famiglia del capitano, anche se al suo servizio rimanevano pur sempre un giudice, un cavaliere, due notai, sei birri e due cavalcature. Il capitano era costretto a mantenere a sue spese la propria famiglia e doveva farla risiedere nel suo palazzo. Nel 1558 fu istituita, all’interno del capitanato di Volterra, la podesteria di Pomarance. Questa circoscrizione giudiziaria venne creata allo scopo di porre rimedio alle difficoltà e ai rischi che gli abitanti di Pomarance e dei comunelli circostanti dovevano affrontare per poter raggiungere il tribunale di Volterra: attraversare il fiume Cecina, infatti, specialmente d’inverno, era estremamente pericoloso. La podesteria di Pomarance comprendeva i comuni di S. Dalmazio, Montecerboli, Micciano, Libbiano e Montegemoli, oltre naturalmente a Pomarance, dove aveva la sede centrale. Nel XVII secolo il potere giurisdizionale del capitano di Volterra fu ridotto a seguito delle infeudazioni di Castelnuovo e di Monteverdi e Canneto. Con la costituzione del marchesato di Castelnuovo, concesso in feudo a Luca di Girolamo degli Albizi l’8 dicembre 1639, l’amministrazione della giustizia divenne appannaggio del neo eletto marchese che la esercitava attraverso un commissario da lui nominato. Nel 1665 Ferdinando II dei Medici costituì il feudo di Monteverdi e Canneto e lo concesse al marchese Ferdinando Incontri, con diritto di successione; le competenze civili e criminali, sottratte al capitano di Volterra, passarono così al vicario di nomina feudale.
Con la riforma giudiziaria leopoldina del 1772 fu istituito il vicariato di Volterra, nella cui giurisdizione rientrarono fino al 1781 le podesterie di Pomarance e Montecastelli, dal 1782 al 1784 quelle di Pomarance e Castelnuovo (competente su Montecastelli e Silano) e, dal 1784, solo quella di Pomarance (competente su Pomarance e Castelnuovo). Con la dominazione francese il vicariato di Volterra fu soppresso. Volterra divenne sede di giudicatura di pace, competente anche su Montecatini, e di tribunale di prima istanza, mentre la corte criminale per le cause penali maggiori era a Pisa. Con la Restaurazione fu ricostituito il vicariato di Volterra e il 14 marzo 1816 fu eretto in commissariato, con una circoscrizione comprensiva anche dei vicariati di Campiglia, Piombino e Colle Val d’Elsa. Con il motuproprio del 2 agosto 1838 Volterra fu sede di commissariato regio, nella cui giurisdizione rientrava la podesteria di Pomarance. Il commissariato regio di Volterra fu abrogato con la riforma del 9 marzo 1848, che istituì il tribunale di Volterra, nel cui circondario vi erano le preture civili e criminali di Volterra (competente sulle comunità di Volterra e Montecatini), Gherardesca (competente sull’omonima comunità), Campiglia (competente sulle comunità di Campiglia, Suvereto, Sassetta e Monteverdi) e Piombino (competente sull’omonima comunità) e le preture civili di Pomarance (competente sulle comunità di Pomarance e Castelnuovo) e Guardistallo (competente sulle comunità di Guardistallo, Montescudaio, Casale e Bibbona). Nel 1865 anche Volterra divenne sede di un Giudice Conciliatore di nomina regia che giudicava le cause minori su richiesta delle parti. La legge 16 giugno 1892 n. 261 dettò le regole per il funzionamento dell'ufficio di conciliazione retto da un giudice che aveva pertinenza nelle cause relative a “azioni personali, civili e commerciali” e “danni dati” fino a cento lire di valore e a locazioni di immobili. Il giudice era scelto dal Presidente del Tribunale, su proposta del procuratore regio, da una lista compilata periodicamente dalla giunta comunale. Ulteriore regolamentazione in materia è contenuta nella legge 18 dicembre 1941 n. 1368.
Da un punto di vista amministrativo Volterra fu sede di cancelleria fin dalla metà degli anni ’60 del Cinquecento. Fu interessata dalla riforma comunitativa leopoldina nel 1772, diversamente da tutte le altre comunità del distretto fiorentino, per le quali il regolamento generale fu emanato il 29 settembre 1774 e quello particolare il 1 aprile 1776. Con motuproprio granducale del 15 maggio 1779 si ebbe una seconda e definitiva riforma amministrativa, in base alla quale la comunità di Volterra venne a comprendere le contrade di Selci, S. Agnolo, Piazza, Borgo S. Stefano, Pratomarzio, Montebradoni, S. Giusto, le pendici di S. Michele, S. Pietro, S. Stefano, Pratomarzio, Montebradoni, S. Giusto, S. Alessandro, Villa Magna, Nera e Cozzano, Pignano, Ulignano, Fibbiano, Sensano, S. Anastasio e Spicchiaiola, Ponsano, Monte Buono e Fatagliano, Castro e Castiglione, Buriano e Miemo e gli ex comunelli di Montemiccioli e Spedaletto. Con il motuproprio del 1 novembre 1825 Volterra divenne sede di un ingegnere di circondario dipendente dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa. La figura dell’ingegnere di circondario fu abolita con motuproprio del 20 novembre 1849. Da allora la vigilanza e consulenza tecnica sulle nuove costruzioni e sul mantenimento di corsi d’acqua, strade e fabbriche vennero attribuite agli ingegneri distrettuali e comunali. A seguito del motuproprio del 29 novembre 1826, la cancelleria di Volterra allargò le sue competenze sulla comunità di Montecatini, fino a quel momento appartenuta alla cancelleria di Pomarance. Con il motuproprio del 19 luglio 1841 la cancelleria di Volterra fu classificata, all’interno del compartimento di Firenze, di prima classe e provvista di un aiuto cancelliere. Nel 1849 la cancelleria di Volterra passò dal compartimento fiorentino a quello pisano. In questo stesso anno Volterra divenne sede di sottoprefettura. In base alla legge del 20 marzo 1865 n. 2248 il consiglio comunale di Volterra era formato da trenta consiglieri, compreso il sindaco che lo presiedeva, mentre la giunta da quattro assessori ordinari e due supplenti, eletti dal consiglio, e dal sindaco, con funzioni di presidente. Prima dell’epoca podestarile ci fu un solo commissariamento nel comune di Volterra: nel luglio 1921, infatti, l’amministrazione comunale fu consegnata al commissario prefettizio Filippo Cardelli che rimase in carica fino al 7 gennaio 1923, giorno in cui si svolsero le elezioni. Il 14 gennaio si radunò in via straordinaria il nuovo consiglio e in questa occasione fu nominato sindaco Fabio Guidi e fu ricostituita la giunta. Essa tornò a deliberare il 29 gennaio 1923.
L'ultima deliberazione della giunta prima dell'epoca podestarile fascista è del 25 marzo 1927. A Volterra si sono succeduti tre podestà: Antonio Carraio dal 18 maggio 1927 al 26 luglio 1929, Fabio Guidi dal 30 dicembre 1929 al 1 agosto 1934 e Eugenio Lagorio dal 25 gennaio 1935 al 16 giugno 1940. Sotto il podestà Guidi Volterra cedette al comune di Montecatini nel 1929 la frazione di Buriano e nel 1933 le frazioni di Miemo e Casaglia, ricevendo in cambio Mazzolla. I podestà Guidi e Lagorio, furono affiancati, dal 1933 al 1937, dalla Consulta comunale, organo con funzioni consultive non vincolanti. La Consulta, nominata con decreto prefettizio n. 3560 del 14 ottobre 1932, era composta dal podestà e da 9 membri, dei quali tre di nomina prefettizia, tre in rappresentanza dei datori di lavoro (agricolo, industriale e artigiano) e tre in rappresentanza dei lavoratori (agricoli, dell’industria e intellettuali). Il 18 giugno 1940, a seguito della chiamata alle armi del podestà Eugenio Lagorio, il prefetto nominò, con proprio decreto n. 1799 del 16 giugno, commissario prefettizio Lorenzo Ginori Lisci, che deliberò fino al 16 ottobre 1943. Il 24 ottobre dello stesso anno, a seguito del decreto prefettizio n. 2433 del 17 ottobre, l’amministrazione fu consegnata dal delegato commissariale Paolo Sensi Contugi al nuovo commissario prefettizio Giuseppe Fantozzi. Il Fantozzi rimase in carica fino al 21 dicembre quando fu sostituito, con decreto prefettizio 20 dicembre 1943 n. 2696, dal commissario Manlio Cherici. Il 22 giugno 1944, essendo stato quest’ultimo mobilitato, l’amministrazione comunale fu consegnata al delegato commissariale Mario Borgiotti, che sostituì il delegato commissariale Giulio Cionini, dimissionario. Il 9 luglio 1944, a seguito della liberazione di Volterra dall’occupazione tedesca, il delegato commissariale Borgiotti consegnò l’amministrazione ad Amedeo Meini, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale. Il Meini, in qualità di pro-sindaco, deliberò il 13 e il 14 luglio. Il 17 luglio, con provvedimento del Governo Militare Alleato, fu nominata la nuova giunta comunale, che si radunò per la prima volta il 26 luglio. La seduta però andò deserta per la mancanza del numero legale degli intervenuti. La prima riunione in sede deliberativa della giunta avvenne il 10 agosto successivo. Con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1, che dettò le norme per la ricostituzione delle amministrazioni su base elettiva, fu ristabilito l'ordinamento comunale precedente il Fascismo. Le prime elezioni libere dopo l’epoca fascista si tennero il 24 marzo 1946.
Le cose cambiarono di nuovo di segno nel 1361, quando il principale esponente dei Belforti fu giustiziato e la famiglia cacciata da Volterra. Di questi contrasti approfittò il Comune di Firenze, il quale, attirato anche da prospettive economiche in ambito minerario ed estrattivo e ponendosi come mediatore fra le parti, si assicurò il controllo delle istituzioni urbane volterrane. Firenze riconobbe l'indipendenza di Volterra ma solo formalmente: in realtà, il Capitano del popolo, cioè il più importante magistrato della città, era scelto dalla Dominante che nel 1427 arrivò anche a imporre a Volterra l'applicazione del Catasto. I tentativi di rivendicare degli spazi d'autonomia da parte dei Volterrani furono definitivamente stroncati nel 1472 quando, all'indomani del famoso "sacco di Volterra", la città perse ogni residua forma di autogoverno.
Oltre che come centro di potere autonomo e teatro dell'operato di istituzioni locali, Volterra ebbe particolare rilievo anche come sede di istituzioni designate dall'esterno - in particolare da Firenze - e lì residenti con competenza territoriale estesa al territorio circostante, ampliatosi e contrattosi nel tempo ma sempre ritenuto strategico e importante soprattutto per il fatto di trovarsi in una zona di confine ed estremamente interessante dal punto di vista economico. Ciò è vero in particolare per l'amministrazione della giustizia, attività per la quale i giusdicenti residenti a Volterra hanno prodotto quella cospicua documentazione che oggi costituisce il nucleo più importante dell'archivio storico cittadino. Fino al 1472, infatti, Volterra era sede di un podestà con competenze civili e criminali: il podestà esercitava un grosso controllo giurisdizionale anche sul contado, nominando gli ufficiali di Pomarance, Castelnuovo, Monteverdi, Montecatini, nonché il podestà della montagna volterrana che si occupava, con l’aiuto di cinque notai scelti fra cittadini volterrani, dei comuni di Querceto, Gello, Sassa, Montegemoli, Micciano, Libbiano, Lustignano, Serrazzano, S. Dalmazio, Montecerboli, Sasso, Leccia, Castelvolterrano e Mazzolla. Con il sacco fiorentino, compiuto nel giugno del 1472, Volterra perse completamente il controllo giurisdizionale sul contado. L’istituzione del vicariato di Val di Cecina, con sede, prima, alternata tra Pomarance e Castelnuovo e, poi, definitiva a Pomarance, avvenuta nel luglio seguente, significò per Volterra perdere le proprie competenze civili e criminali su un vasto territorio, che si estendeva sulla riva sinistra e destra del fiume Cecina fino ai confini con lo stato senese, parzialmente segnati dal fiume Cornia. Con la sottomissione a Firenze fu stabilito anche che il capitano, con poteri civili e criminali, dovesse essere un ufficiale fiorentino: le sue sentenze criminali erano inappellabili, mentre per quelle civili il tribunale d’appello era rappresentato dalla Corte del Capitano della città di Firenze. La nuova organizzazione data al territorio volterrano all’indomani del sacco non ebbe, però, carattere stabile. Il 5 ottobre del 1513, infatti, per premiare la fedeltà di Volterra a Firenze, il vicariato di Val di Cecina fu soppresso ed i territori in esso compresi furono assegnati nuovamente a Volterra, che riacquistò la facoltà di inviarvi propri rettori di giustizia, come avveniva anteriormente al 1472. Tali rettori giudicavano le cause civili inferiori alle venticinque lire; contro le loro sentenze era ammesso unicamente l’appello davanti al podestà di Volterra. La balìa del 5 ottobre 1513, inoltre, restituì, a Volterra gran parte degli antichi privilegi: venne ripristinato il tribunale dei priori e fu nuovamente istituita la carica del podestà, che era stata soppressa nel 1472 a seguito del sacco; fu però stabilito che la sua nomina fosse di competenza fiorentina. Il podestà tornò ad avere competenze civili, mentre al capitano rimasero quelle criminali; la giurisdizione del danno dato passò ad un apposito ufficiale. Il 19 gennaio 1528 l’ultima repubblica fiorentina, allo scopo di colpire Volterra rimasta fedele al partito mediceo, soppresse la carica del podestà, riaffidando tutti i poteri giudiziari al capitano e istituendo di nuovo nel contado, anche se per un breve periodo (1528-1530), il vicariato di Val di Cecina, con gli stessi poteri che aveva avuto fino all’ottobre del 1513. Volterra perse, così, nuovamente il diritto di eleggere ed inviare giusdicenti nel contado. Al ritorno dei Medici, il 10 dicembre 1530, il vicariato di Val di Cecina fu soppresso per la seconda volta, ma non fu ripristinata la podesteria di Volterra; tutti i poteri furono attribuiti al capitano di Volterra, il quale, data la difficile situazione dell’ordine pubblico nella fascia meridionale dello Stato, fu anche nominato commissario con il compito di affiancare nel penale il capitano di Campiglia e di Gherardesca e di svolgere il ruolo di polizia confinaria. La provvisione del 3 giugno 1531 eliminò il capitanato di Campiglia tra le competenze del capitano di Volterra, al quale furono nuovamente attribuite competenze criminali, civili e sul danno dato. Nel contado integravano l’attività del capitano sette ufficiali: quello di Castelnuovo, quello di Montecastelli, che serviva anche Silano, quello di Pomarance, con competenza anche su Montecerboli e S. Dalmazio, quello di Monteverdi, che serviva anche Canneto, quello di Querceto, con competenze anche su Sassa, Micciano, Libbiano e Montegemoli, quello del Sasso, che serviva anche Serrazzano, Leccia e Lustignano e quello di Montecatini, con competenza anche su Gello. Dei sette ufficiali del contado, due, quello di Castelnuovo e quello di Montecastelli, venivano nominati localmente, gli altri erano inviati dal capitano di Volterra, che li doveva scegliere tra i notai abili di questa città.
La legge del 13 febbraio 1546 ridimensionò il numero dei componenti la famiglia del capitano, anche se al suo servizio rimanevano pur sempre un giudice, un cavaliere, due notai, sei birri e due cavalcature. Il capitano era costretto a mantenere a sue spese la propria famiglia e doveva farla risiedere nel suo palazzo. Nel 1558 fu istituita, all’interno del capitanato di Volterra, la podesteria di Pomarance. Questa circoscrizione giudiziaria venne creata allo scopo di porre rimedio alle difficoltà e ai rischi che gli abitanti di Pomarance e dei comunelli circostanti dovevano affrontare per poter raggiungere il tribunale di Volterra: attraversare il fiume Cecina, infatti, specialmente d’inverno, era estremamente pericoloso. La podesteria di Pomarance comprendeva i comuni di S. Dalmazio, Montecerboli, Micciano, Libbiano e Montegemoli, oltre naturalmente a Pomarance, dove aveva la sede centrale. Nel XVII secolo il potere giurisdizionale del capitano di Volterra fu ridotto a seguito delle infeudazioni di Castelnuovo e di Monteverdi e Canneto. Con la costituzione del marchesato di Castelnuovo, concesso in feudo a Luca di Girolamo degli Albizi l’8 dicembre 1639, l’amministrazione della giustizia divenne appannaggio del neo eletto marchese che la esercitava attraverso un commissario da lui nominato. Nel 1665 Ferdinando II dei Medici costituì il feudo di Monteverdi e Canneto e lo concesse al marchese Ferdinando Incontri, con diritto di successione; le competenze civili e criminali, sottratte al capitano di Volterra, passarono così al vicario di nomina feudale.
Con la riforma giudiziaria leopoldina del 1772 fu istituito il vicariato di Volterra, nella cui giurisdizione rientrarono fino al 1781 le podesterie di Pomarance e Montecastelli, dal 1782 al 1784 quelle di Pomarance e Castelnuovo (competente su Montecastelli e Silano) e, dal 1784, solo quella di Pomarance (competente su Pomarance e Castelnuovo). Con la dominazione francese il vicariato di Volterra fu soppresso. Volterra divenne sede di giudicatura di pace, competente anche su Montecatini, e di tribunale di prima istanza, mentre la corte criminale per le cause penali maggiori era a Pisa. Con la Restaurazione fu ricostituito il vicariato di Volterra e il 14 marzo 1816 fu eretto in commissariato, con una circoscrizione comprensiva anche dei vicariati di Campiglia, Piombino e Colle Val d’Elsa. Con il motuproprio del 2 agosto 1838 Volterra fu sede di commissariato regio, nella cui giurisdizione rientrava la podesteria di Pomarance. Il commissariato regio di Volterra fu abrogato con la riforma del 9 marzo 1848, che istituì il tribunale di Volterra, nel cui circondario vi erano le preture civili e criminali di Volterra (competente sulle comunità di Volterra e Montecatini), Gherardesca (competente sull’omonima comunità), Campiglia (competente sulle comunità di Campiglia, Suvereto, Sassetta e Monteverdi) e Piombino (competente sull’omonima comunità) e le preture civili di Pomarance (competente sulle comunità di Pomarance e Castelnuovo) e Guardistallo (competente sulle comunità di Guardistallo, Montescudaio, Casale e Bibbona). Nel 1865 anche Volterra divenne sede di un Giudice Conciliatore di nomina regia che giudicava le cause minori su richiesta delle parti. La legge 16 giugno 1892 n. 261 dettò le regole per il funzionamento dell'ufficio di conciliazione retto da un giudice che aveva pertinenza nelle cause relative a “azioni personali, civili e commerciali” e “danni dati” fino a cento lire di valore e a locazioni di immobili. Il giudice era scelto dal Presidente del Tribunale, su proposta del procuratore regio, da una lista compilata periodicamente dalla giunta comunale. Ulteriore regolamentazione in materia è contenuta nella legge 18 dicembre 1941 n. 1368.
Da un punto di vista amministrativo Volterra fu sede di cancelleria fin dalla metà degli anni ’60 del Cinquecento. Fu interessata dalla riforma comunitativa leopoldina nel 1772, diversamente da tutte le altre comunità del distretto fiorentino, per le quali il regolamento generale fu emanato il 29 settembre 1774 e quello particolare il 1 aprile 1776. Con motuproprio granducale del 15 maggio 1779 si ebbe una seconda e definitiva riforma amministrativa, in base alla quale la comunità di Volterra venne a comprendere le contrade di Selci, S. Agnolo, Piazza, Borgo S. Stefano, Pratomarzio, Montebradoni, S. Giusto, le pendici di S. Michele, S. Pietro, S. Stefano, Pratomarzio, Montebradoni, S. Giusto, S. Alessandro, Villa Magna, Nera e Cozzano, Pignano, Ulignano, Fibbiano, Sensano, S. Anastasio e Spicchiaiola, Ponsano, Monte Buono e Fatagliano, Castro e Castiglione, Buriano e Miemo e gli ex comunelli di Montemiccioli e Spedaletto. Con il motuproprio del 1 novembre 1825 Volterra divenne sede di un ingegnere di circondario dipendente dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa. La figura dell’ingegnere di circondario fu abolita con motuproprio del 20 novembre 1849. Da allora la vigilanza e consulenza tecnica sulle nuove costruzioni e sul mantenimento di corsi d’acqua, strade e fabbriche vennero attribuite agli ingegneri distrettuali e comunali. A seguito del motuproprio del 29 novembre 1826, la cancelleria di Volterra allargò le sue competenze sulla comunità di Montecatini, fino a quel momento appartenuta alla cancelleria di Pomarance. Con il motuproprio del 19 luglio 1841 la cancelleria di Volterra fu classificata, all’interno del compartimento di Firenze, di prima classe e provvista di un aiuto cancelliere. Nel 1849 la cancelleria di Volterra passò dal compartimento fiorentino a quello pisano. In questo stesso anno Volterra divenne sede di sottoprefettura. In base alla legge del 20 marzo 1865 n. 2248 il consiglio comunale di Volterra era formato da trenta consiglieri, compreso il sindaco che lo presiedeva, mentre la giunta da quattro assessori ordinari e due supplenti, eletti dal consiglio, e dal sindaco, con funzioni di presidente. Prima dell’epoca podestarile ci fu un solo commissariamento nel comune di Volterra: nel luglio 1921, infatti, l’amministrazione comunale fu consegnata al commissario prefettizio Filippo Cardelli che rimase in carica fino al 7 gennaio 1923, giorno in cui si svolsero le elezioni. Il 14 gennaio si radunò in via straordinaria il nuovo consiglio e in questa occasione fu nominato sindaco Fabio Guidi e fu ricostituita la giunta. Essa tornò a deliberare il 29 gennaio 1923.
L'ultima deliberazione della giunta prima dell'epoca podestarile fascista è del 25 marzo 1927. A Volterra si sono succeduti tre podestà: Antonio Carraio dal 18 maggio 1927 al 26 luglio 1929, Fabio Guidi dal 30 dicembre 1929 al 1 agosto 1934 e Eugenio Lagorio dal 25 gennaio 1935 al 16 giugno 1940. Sotto il podestà Guidi Volterra cedette al comune di Montecatini nel 1929 la frazione di Buriano e nel 1933 le frazioni di Miemo e Casaglia, ricevendo in cambio Mazzolla. I podestà Guidi e Lagorio, furono affiancati, dal 1933 al 1937, dalla Consulta comunale, organo con funzioni consultive non vincolanti. La Consulta, nominata con decreto prefettizio n. 3560 del 14 ottobre 1932, era composta dal podestà e da 9 membri, dei quali tre di nomina prefettizia, tre in rappresentanza dei datori di lavoro (agricolo, industriale e artigiano) e tre in rappresentanza dei lavoratori (agricoli, dell’industria e intellettuali). Il 18 giugno 1940, a seguito della chiamata alle armi del podestà Eugenio Lagorio, il prefetto nominò, con proprio decreto n. 1799 del 16 giugno, commissario prefettizio Lorenzo Ginori Lisci, che deliberò fino al 16 ottobre 1943. Il 24 ottobre dello stesso anno, a seguito del decreto prefettizio n. 2433 del 17 ottobre, l’amministrazione fu consegnata dal delegato commissariale Paolo Sensi Contugi al nuovo commissario prefettizio Giuseppe Fantozzi. Il Fantozzi rimase in carica fino al 21 dicembre quando fu sostituito, con decreto prefettizio 20 dicembre 1943 n. 2696, dal commissario Manlio Cherici. Il 22 giugno 1944, essendo stato quest’ultimo mobilitato, l’amministrazione comunale fu consegnata al delegato commissariale Mario Borgiotti, che sostituì il delegato commissariale Giulio Cionini, dimissionario. Il 9 luglio 1944, a seguito della liberazione di Volterra dall’occupazione tedesca, il delegato commissariale Borgiotti consegnò l’amministrazione ad Amedeo Meini, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale. Il Meini, in qualità di pro-sindaco, deliberò il 13 e il 14 luglio. Il 17 luglio, con provvedimento del Governo Militare Alleato, fu nominata la nuova giunta comunale, che si radunò per la prima volta il 26 luglio. La seduta però andò deserta per la mancanza del numero legale degli intervenuti. La prima riunione in sede deliberativa della giunta avvenne il 10 agosto successivo. Con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1, che dettò le norme per la ricostituzione delle amministrazioni su base elettiva, fu ristabilito l'ordinamento comunale precedente il Fascismo. Le prime elezioni libere dopo l’epoca fascista si tennero il 24 marzo 1946.
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
preunitario (sec. XII fine - 1865)
ente pubblico territoriale
Profili istituzionali collegati:
Comunità (Granducato di Toscana), 1774 - 1808
Mairie (Impero francese), 1805 - 1814
Comunità (Granducato di Toscana), 1814 - 1865
Comune, 1859 -
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Volterra (complesso di fondi / superfondo)
Redazione e revisione:
Gelli Simona, revisione
Morotti Laura, 2020/11, revisione
Trovato Silvia, 2020/11, revisione
Valgimogli Lorenzo, 2021/01, supervisione della scheda