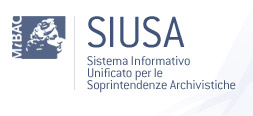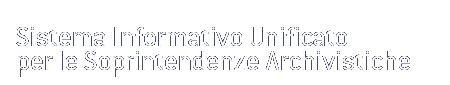Date di esistenza: sec. XV - 1806
Intestazioni:
Universitas di Noci, Noci (Bari), sec. XV - 1806, SIUSA
L'esistenza di un casale denominato Santa Maria delle Noci è attestata sin dal 1180, quando l'arcivescovo Rainaldo di Bari, in nome di papa Alessandro III, riconobbe l'omonima chiesa sotto la giurisdizione del vescovo di Conversano Cafisio [cfr. P. GENTILE, 'Noci: le grandi questioni storiche. Saggi nel bicentenario della nascita di Pietro Gioia', Putignano, V. Radio, 2003, p. 72]. Il primo nucleo di case sorse intorno alla chiesa, come testimonia l'identificazione onomastica che si ritrova in un documento risalente al 1240, in cui l'imperatore Federico II ordinava agli abitanti del casale di Santa Maria delle Noci di contribuire alla manutenzione del castello di Ruvo [ibidem]. Si tratta tuttavia di un contributo straordinario e non di una regolare tassazione, segno evidente che il casale non aveva ancora raggiunto uno sviluppo e un'autonomia tali da giustificare la sua inclusione nei registri delle Cedole angioine, in cui è attestato solo a partire dal 1340.
Tra la metà del XIII secolo e i primi anni del XV, la trasformazione della chiesa da luogo di preghiera in parrocchia si accompagna all'evoluzione di Noci da "castellum" a "civitas" [A. FANELLI, 'La più antica platea della città: cultura, economia e fede nella Noci del '400', Noci, Parrocchia Maria Ss. della Natività, 1999, p. 99] e da casale in "terra": nelle fonti documentarie la "Terra Nucum" ossia "Terra delle Noci" appare ormai come un organismo che costruisce la propria identità geografica e giuridica pronto per esigere una chiara delimitazione del proprio territorio al fine di ottenere i benefici derivanti dal godimento degli usi civici.
Il primo riconoscimento civico della "Terra delle Noci" risale a un privilegio concesso da re Ladislao il 23 aprile 1407, come premio per la fedeltà dimostratagli dai nocesi che si ribellarono al loro feudatario Margherita del Balzo, contessa di Conversano e moglie di Pietro il Lussemburgo: il re annetteva la Terra al suo dominio e la sottoponeva alla sua "real corona", confermando agli abitanti "tutte le immunità, e consuetudini da' medesimi godute colle terre del Principato di Taranto in riguardo all'uso dell'acqua, erbe, franchizie, caccia, ed ogni altra cosa per essi fin'allora goduta" [P. GENTILE, 'Trasformazioni storiche del territorio. Questione territoriale e questione demaniale a Noci dal XV secolo agli inizi del Novecento', in "Riflessioni. Umanesimo della pietra", a cura del gruppo Umanesimo della pietra, Martina Franca, Arti grafiche pugliesi, 2000, pp. 41-9, cit. a p. 42].
Tuttavia, già nel 1440 la Terra fu rivendicata dal principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsini che nel 1456 la cedette in dote alla figlia Caterina, sposa di Giulio Antonio Acquaviva: da allora Noci rimase sotto la giurisdizione della Contea di Conversano fino alla soppressione della feudalità avvenuta nel 1806.
Nel corso dei secoli si verificarono dispute relative al possesso e all'uso del territorio circostante da parte di Noci: al centro della contesa era la comunanza degli usi civici con la vicina Mottola e il ruolo a questa arbitrariamente attribuito di "grande terra madre" che giustificasse lo "jus filiationis" di Noci nei suoi possedimenti. Un capitolo importante di questa disputa fu un atto di liberalità di un barone mottolese, Giovanni Tommaso Galateù, che nel 1512 concesse ai nocesi "la stessa facoltà per l'addietro goduta nell'intiero territorio di Motola, di poter ivi con loro animali pascere, acquare, tagliare legna, formar foggie, e quelle riparare, e liberamente praticare ogni altra cosa di loro utile, e comodo", specificando che "in tempo di difesa del frutto pendente [ossia la raccolta delle ghiande e/o il pascolo riservato ai maiali dal 29 settembre al 13 dicembre] in detto territorio di Mottola, detta difesa si fermi a tre miglia dalle mura della Terra delle Noci" [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., pp. 43-4]. Tale atto ingenerò interpretazioni divergenti tra nocesi e mottolesi: i primi lo intesero in modo da usurpare definitivamente il territorio promiscuo corrispondente alla distanza di tre miglia dal proprio confine, i secondi per esercitare su di esso in maniera esclusiva i diritti civici. Il Galateù si impegnò ad applicare la benevolenza fino al 1521, quando vendette il feudo di Mottola alla contessa della Saponara che subito rivendicò l'esercizio della "difesa" fino al limite delle mura di Noci. Il territorio delle tre miglia divenne così per oltre due secoli il centro della disputa tra le due comunità, caratterizzato dalla difficile conciliazione tra la promiscuità circa il godimento degli usi civici e l'appartenenza giuridica al demanio mottolese.
Nel 1532 Maria Aldonza Beltrano, contessa della Saponara e titolare della giurisdizione feudale sul territorio di Mottola, chiese ed ottenne dall'imperatore Carlo V, con decreto del 19 aprile 1537, la riapertura dei fondi usurpati, coltivati e chiusi dai nocesi. Il decreto fu confermato a conclusione del giudizio d'appello promosso dall'Università di Noci con sentenza del Sacro regio consiglio del 15 luglio 1545, che non ebbe completa attuazione perché anticipato da un accordo firmato nel gennaio del 1543 e ratificato con atto notarile il 22 marzo 1546 e con regio assenso il 20 maggio dello stesso anno. Tale accordo ("capitolazioni" o "concordia") prevedeva il pagamento di 3.500 ducati da parte dei nocesi e la rinuncia a contrastare in giudizio la pretesa dei mottolesi di ridurre a pascolo comune le difese già costruite; in cambio l'Università di Noci otteneva il ripristino dello stato precedente all'applicazione della sentenza relativamente ai parchi e alle chiusure demoliti [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., pp. 47-8].
Le "capitolazioni" furono rispettate fino alla morte della contessa della Saponara e immediatamente contestate dinanzi al Sacro regio consiglio dai suoi successori, Nicolò Maria Seripanno e il figlio Marcantonio; si giunse quindi alla sottoscrizione di una nuova "convenzione di concordia" che in sostanza, con regio assenso del 16 settembre 1594 e atti notarili del 15 aprile e 21 agosto 1595, ratificava la "capitolazione" della contessa della Saponara con l'impegno da parte dei nocesi di corrispondere ulteriori 2.000 ducati oltre al pagamento degli interessi e degli arretrati, e di contro il privilegio di usufruire dei parchi e delle chiusure eretti dopo il 1532 [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., p. 47].
Il secondo accordo fu contestato solo agli inizi del Settecento, tanto da indurre il Sacro regio consiglio a inviare sul posto nel 1704 il consigliere Giambattista Pisacano e il tavolario Donato Gallarano con il compito di redigere "la pianta ed una distintissima relazione, in cui si veggono, e leggono la circonferenza delle tre miglia delle Noci, e le contrade tutte, e luoghi controversi, e riferite le scambievoli pretensioni delle parti" [P. Gentile, Trasformazioni cit., p. 48]. Nel 1724 il duca di Martina, nel frattempo divenuto feudatario di Mottola, richiese l'intervento del regio consigliere Matteo Ferrante che sciolse ogni promiscuità sugli usi civici del territorio assegnando all'Università di Noci parti delle contrade Poltri, Murgia, Pentima o Bonelli e Barsento [Ibidem]. Il decreto fu sostanzialmente ratificato da un atto notarile del 30 dicembre 1739 stipulato tra il duca di Martina, il conte di Conversano, le università di Noci e Mottola e altre popolazioni, con il quale i nocesi acquisirono un'abbondante porzione del territorio mottolese.
Alla vigilia della definitiva abolizione della feudalità, sancita con la legge del Regno di Napoli 2 agosto 1806 n. 130, l'Università di Noci, destinata ancora per poco tempo ad essere feudo dei conti di Conversano, era così descritta: "Tiene un bosco abbondante di ghiande appellato la Parata, il quale si appartiene all'Università, e questa difesa incomincia da' 29 settembre, e finisce a 13 dicembre, ricavandone dagli affitti annui ducati 3.000 incirca. Gli abitanti in oggi ascendono presso ad 8.000: vi è tra loro del commercio con altre popolazione della provincia e fuori. Vi sono un ospedale, e due monti di maritaggi. Si possiede dalla famiglia Acquaviva di Aragona. Nel 1532 fu tassata per fuochi 531, nel 1545 per 643, nel 1561 per 688, nel 1595 per 807, nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1669 per 598. Nell'ultima numerazione del 1737 per 5.880. Da ciò vedesi esser stata sempre una terra popolata" [L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli [Napoli, Vincenzo Manfredi, poi Stamperia di Giovanni de Bonis, 1797-1816], rist. anast. Bologna, Forni, 1969-1971, 13 voll., t. VII, p. 49]. (a cura di A. LUCCHI)
Il primo riconoscimento civico della "Terra delle Noci" risale a un privilegio concesso da re Ladislao il 23 aprile 1407, come premio per la fedeltà dimostratagli dai nocesi che si ribellarono al loro feudatario Margherita del Balzo, contessa di Conversano e moglie di Pietro il Lussemburgo: il re annetteva la Terra al suo dominio e la sottoponeva alla sua "real corona", confermando agli abitanti "tutte le immunità, e consuetudini da' medesimi godute colle terre del Principato di Taranto in riguardo all'uso dell'acqua, erbe, franchizie, caccia, ed ogni altra cosa per essi fin'allora goduta" [P. GENTILE, 'Trasformazioni storiche del territorio. Questione territoriale e questione demaniale a Noci dal XV secolo agli inizi del Novecento', in "Riflessioni. Umanesimo della pietra", a cura del gruppo Umanesimo della pietra, Martina Franca, Arti grafiche pugliesi, 2000, pp. 41-9, cit. a p. 42].
Tuttavia, già nel 1440 la Terra fu rivendicata dal principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsini che nel 1456 la cedette in dote alla figlia Caterina, sposa di Giulio Antonio Acquaviva: da allora Noci rimase sotto la giurisdizione della Contea di Conversano fino alla soppressione della feudalità avvenuta nel 1806.
Nel corso dei secoli si verificarono dispute relative al possesso e all'uso del territorio circostante da parte di Noci: al centro della contesa era la comunanza degli usi civici con la vicina Mottola e il ruolo a questa arbitrariamente attribuito di "grande terra madre" che giustificasse lo "jus filiationis" di Noci nei suoi possedimenti. Un capitolo importante di questa disputa fu un atto di liberalità di un barone mottolese, Giovanni Tommaso Galateù, che nel 1512 concesse ai nocesi "la stessa facoltà per l'addietro goduta nell'intiero territorio di Motola, di poter ivi con loro animali pascere, acquare, tagliare legna, formar foggie, e quelle riparare, e liberamente praticare ogni altra cosa di loro utile, e comodo", specificando che "in tempo di difesa del frutto pendente [ossia la raccolta delle ghiande e/o il pascolo riservato ai maiali dal 29 settembre al 13 dicembre] in detto territorio di Mottola, detta difesa si fermi a tre miglia dalle mura della Terra delle Noci" [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., pp. 43-4]. Tale atto ingenerò interpretazioni divergenti tra nocesi e mottolesi: i primi lo intesero in modo da usurpare definitivamente il territorio promiscuo corrispondente alla distanza di tre miglia dal proprio confine, i secondi per esercitare su di esso in maniera esclusiva i diritti civici. Il Galateù si impegnò ad applicare la benevolenza fino al 1521, quando vendette il feudo di Mottola alla contessa della Saponara che subito rivendicò l'esercizio della "difesa" fino al limite delle mura di Noci. Il territorio delle tre miglia divenne così per oltre due secoli il centro della disputa tra le due comunità, caratterizzato dalla difficile conciliazione tra la promiscuità circa il godimento degli usi civici e l'appartenenza giuridica al demanio mottolese.
Nel 1532 Maria Aldonza Beltrano, contessa della Saponara e titolare della giurisdizione feudale sul territorio di Mottola, chiese ed ottenne dall'imperatore Carlo V, con decreto del 19 aprile 1537, la riapertura dei fondi usurpati, coltivati e chiusi dai nocesi. Il decreto fu confermato a conclusione del giudizio d'appello promosso dall'Università di Noci con sentenza del Sacro regio consiglio del 15 luglio 1545, che non ebbe completa attuazione perché anticipato da un accordo firmato nel gennaio del 1543 e ratificato con atto notarile il 22 marzo 1546 e con regio assenso il 20 maggio dello stesso anno. Tale accordo ("capitolazioni" o "concordia") prevedeva il pagamento di 3.500 ducati da parte dei nocesi e la rinuncia a contrastare in giudizio la pretesa dei mottolesi di ridurre a pascolo comune le difese già costruite; in cambio l'Università di Noci otteneva il ripristino dello stato precedente all'applicazione della sentenza relativamente ai parchi e alle chiusure demoliti [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., pp. 47-8].
Le "capitolazioni" furono rispettate fino alla morte della contessa della Saponara e immediatamente contestate dinanzi al Sacro regio consiglio dai suoi successori, Nicolò Maria Seripanno e il figlio Marcantonio; si giunse quindi alla sottoscrizione di una nuova "convenzione di concordia" che in sostanza, con regio assenso del 16 settembre 1594 e atti notarili del 15 aprile e 21 agosto 1595, ratificava la "capitolazione" della contessa della Saponara con l'impegno da parte dei nocesi di corrispondere ulteriori 2.000 ducati oltre al pagamento degli interessi e degli arretrati, e di contro il privilegio di usufruire dei parchi e delle chiusure eretti dopo il 1532 [P. GENTILE, 'Trasformazioni' cit., p. 47].
Il secondo accordo fu contestato solo agli inizi del Settecento, tanto da indurre il Sacro regio consiglio a inviare sul posto nel 1704 il consigliere Giambattista Pisacano e il tavolario Donato Gallarano con il compito di redigere "la pianta ed una distintissima relazione, in cui si veggono, e leggono la circonferenza delle tre miglia delle Noci, e le contrade tutte, e luoghi controversi, e riferite le scambievoli pretensioni delle parti" [P. Gentile, Trasformazioni cit., p. 48]. Nel 1724 il duca di Martina, nel frattempo divenuto feudatario di Mottola, richiese l'intervento del regio consigliere Matteo Ferrante che sciolse ogni promiscuità sugli usi civici del territorio assegnando all'Università di Noci parti delle contrade Poltri, Murgia, Pentima o Bonelli e Barsento [Ibidem]. Il decreto fu sostanzialmente ratificato da un atto notarile del 30 dicembre 1739 stipulato tra il duca di Martina, il conte di Conversano, le università di Noci e Mottola e altre popolazioni, con il quale i nocesi acquisirono un'abbondante porzione del territorio mottolese.
Alla vigilia della definitiva abolizione della feudalità, sancita con la legge del Regno di Napoli 2 agosto 1806 n. 130, l'Università di Noci, destinata ancora per poco tempo ad essere feudo dei conti di Conversano, era così descritta: "Tiene un bosco abbondante di ghiande appellato la Parata, il quale si appartiene all'Università, e questa difesa incomincia da' 29 settembre, e finisce a 13 dicembre, ricavandone dagli affitti annui ducati 3.000 incirca. Gli abitanti in oggi ascendono presso ad 8.000: vi è tra loro del commercio con altre popolazione della provincia e fuori. Vi sono un ospedale, e due monti di maritaggi. Si possiede dalla famiglia Acquaviva di Aragona. Nel 1532 fu tassata per fuochi 531, nel 1545 per 643, nel 1561 per 688, nel 1595 per 807, nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1669 per 598. Nell'ultima numerazione del 1737 per 5.880. Da ciò vedesi esser stata sempre una terra popolata" [L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli [Napoli, Vincenzo Manfredi, poi Stamperia di Giovanni de Bonis, 1797-1816], rist. anast. Bologna, Forni, 1969-1971, 13 voll., t. VII, p. 49]. (a cura di A. LUCCHI)
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
preunitario
Soggetti produttori:
Comune di Noci, successore
Profili istituzionali collegati:
Universitas (Regno di Napoli), sec. XIII - 1806
Complessi archivistici prodotti:
Atti particolari (sub-fondo / sezione)
Comune di Noci (fondo)
Conclusioni del Parlamento e deliberazioni del Decurionato (serie)
Conti comunali (serie)
Finanze (sottoserie)
Bibliografia:
P. GENTILE, 'Trasformazioni storiche del territorio. Questione territoriale e questione demaniale a Noci dal XV secolo agli inizi del Novecento', in 'Riflessioni. Umanesimo della pietra', a cura del gruppo Umanesimo della pietra, Martina Franca, Arti grafiche pugliesi, 2000, pp. 41-49.
P. GENTILE, 'Noci: le grandi questioni storiche. Saggi nel bicentenario della nascita di Pietro Gioia', Putignano, V. Radio, 2003.
Redazione e revisione:
Mincuzzi Antonella - supervisore Rita Silvestri, 2017/07/11, prima redazione