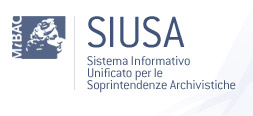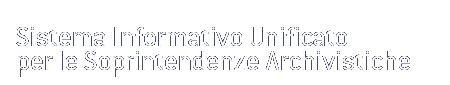Date di esistenza: sec. XIII - 1806
Intestazioni:
Universitas di Rutigliano, Rutigliano (Bari), sec. XIII - 1806, SIUSA
Altre denominazioni:
Universitas di Rotigliano, sec. XVIII
Le vicende che hanno determinato la nascita del comune di Rutigliano sono strettamente legate alla secolare condizione di feudo della basilica di San Nicola di Bari e alle controversie sorte con il capitolo al fine di sottrarsi ai diritti accampati dalla Chiesa e di emanciparsi da ogni vincolo di natura feudale. Tali diritti erano stati concessi, con il consenso del pontefice Bonifacio VIII, dal re angioino Carlo II, che in un primo momento donò in feudo alla basilica metà del castello di Rutigliano insieme a quello di Sannicandro (atto del 1° novembre 1304: "Codice diplomatico barese", vol. XIII: "Le pergamene di San Nicola di Bari: periodo angioino (1266-1309)", a cura di Francesco Nitti di Vito, Trani, Vecchi, 1936, documento n. 135, p. 205; "L'archivio della Basilica di S. Nicola di Bari. Fondo cartaceo", a cura di Domenica Porcaro Massafra, Bari, Edipuglia, 1988, p. XIV), assegnando nel 1306 l'altra metà del castello, del valore di 100 once d'oro, per il sostentamento del clero ("Codice" cit., vol. XIII, documenti n. 146-147, pp. 227-29; "L'archivio" cit., p. XIV). La gestione del patrimonio della basilica, regolata per oltre cinque secoli dalle "costituzioni" dettate da Carlo II con atto del 20 luglio 1304 ("Codice" cit., vol. XIII, documento n. 133, pp. 196-201; "L'archivio" cit., pp. XIV-XX), era differenziata in diversi rami di amministrazione, sia perché le disposizioni reali prevedevano la distribuzione delle rendite al clero a seconda delle cariche ricoperte da ognuno e del servizio prestato, sia per rispettare le particolari destinazioni volute dagli oblatori dei diversi beni. Secondo le "costituzioni" il capitolo era composto dai canonici della chiesa, e i componenti del clero ad essa addetto non dovevano superare il numero massimo di cento, oltre il priore; tra questi, quarantadue dovevano essere i "canonici", incluse le tre dignità del tesoriere, del cantore e del subcantore, ventotto i chierici "mediocres" e trenta i chierici "infimi". Il feudo di Rutigliano, gestito insieme a quello di Sannicandro, rientrava nell'amministrazione detta dei "beni di quinto" poiché le relative rendite erano assegnate per un quinto al priore e per la restante parte ai canonici e al clero "mediocre e infimo" in ragione del servizio prestato. Fino alla fine del XVII sec. la gestione dei due feudi fu affidata al tesoriere, che successivamente si limitò a distribuire le rendite agli aventi diritto e a lui subentrò un "amministratore dei beni di quinto" o "deputato ai feudi". Secondo la volontà di Carlo II, le quote dei canonicati e dei benefici minori vacanti furono generalmente destinate alla manutenzione delle fabbriche della chiesa e talvolta redistribuite tra i canonici.
Nel XVIII sec. la gestione dei due feudi fu oggetto di lunghe controversie tra le università di Rutigliano e Sannicandro e il capitolo della basilica, particolarmente nell'amministrazione della giustizia civile e criminale che la chiesa gestiva attraverso le sue corti baronali con numerose interferenze da parte dei "padroni dei tre casi criminali", ossia di feudatari o rappresentanti regi detentori della giurisdizione criminale che prevedeva come pena la morte, la rescissione delle membra e l'esilio. Le controversie si risolsero nel 1738 con l'acquisto da parte della basilica di tale giurisdizione criminale insieme alla portolania di Rutigliano (Archivio della Basilica di San Nicola di Bari, Fondo cartaceo. Archivio capitolare: Rutigliano, fascc. 147 (1738) e 155 (1757-1777); cfr. "L'archivio" cit., pp. XIV e 244). Altra fonte di contese erano i conflitti di competenza nell'esazione delle contribuzioni fiscali derivanti dalle notevoli ingerenze da parte del regio Fisco nei rapporti tra la basilica e le università di Rutigliano e Sannicandro; queste si fecero promotrici, prima davanti alla Camera della sommaria e alla Curia del Cappellano maggiore (1714-1805), successivamente davanti alla Commissione feudale (1806-1809), di una lunga causa contro il capitolo per esigere il pagamento di contributi non dovuti per l'esenzione di cui la Chiesa godeva sin dal tempo dei re angioini (Archivio della Basilica di San Nicola di Bari, Fondo cartaceo. Archivio capitolare: Rutigliano, fascc. 139 (1714-1805) e 176 (1806-1809); cfr. "L'archivio" cit., pp. XIV-XV n. 29, pp. 243 e 246). Abolita la feudalità con legge del Regno di Napoli 2 agosto 1806 n. 130, la terra di Rutigliano fu assoggettata direttamente al regio demanio, ma fino alla fine del XIX sec. la basilica continuò a possedere e ad amministrare autonomamente alcuni beni feudali situati nel territorio dell'università, avendo ottenuto, con reale rescritto del 15 settembre 1818, la facoltà di gestirsi secondo gli antichi statuti. A seguito degli attriti sorti tra l'arcivescovo di Bari e il priore di S. Nicola sull'esenzione della basilica dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano, tutti i beni e le rendite della chiesa furono posti sotto sequestro e amministrati direttamente dal regio commissario straordinario Raffaele Lombardi (decreto del ministero di Grazia e giustizia e dei culti del 19 maggio 1890: "L'archivio" cit., p. XXI). Nel 1893 la "regia delegazione per l'amministrazione civile delle reali basiliche palatine pugliesi" subentrò al commissario straordinario nella gestione del patrimonio della chiesa, provvedendo alla vendita di gran parte dei beni immobili appartenenti alla basilica ("L'archivio" cit., pp. XXII-XXIII).
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
preunitario
Soggetti produttori:
Comune di Rutigliano, successore
Profili istituzionali collegati:
Universitas (Regno di Napoli), sec. XIII - 1806
Complessi archivistici prodotti:
Amministrazione (serie)
Comune di Rutigliano (fondo)
Redazione e revisione:
Mincuzzi Antonella - supervisore Rita Silvestri, 2015/09/07, prima redazione