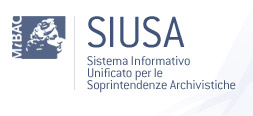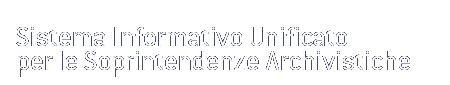Date di esistenza: 1639 -
Intestazioni:
Confraternita di San Vito, Trani, [1639]-, SIUSA
La Congrega di San Vito, in precedenza di Santa Maria de' Bianchi, risale da alcuni documenti al 1466, anche se nel XV secolo, esistendo un Ospedale a Trani con la stessa denominazione, si pensa a qualche collegamento con il movimento dei Bianchi, che, nel 1399, fino ai primi due decenni del Quattrocento, dedicò particolare devozione alla Vergine.
Nel XV secolo è ricordato un Ospedale a Trani, quello di S. Maria de' Bianchi, i cui amministratori, come risulta dai documenti, gestiscono una casa in data 12 dicembre 1466. La denominazione lascia pensare a qualche collegamento con il movimento penitenziale dei Bianchi che, esploso nel 1399, sopravvisse fino ai primi decenni del Quattrocento, avendo tra l'altro come suo tratto distintivo una particolare devozione alla Vergine. Che dietro l'Ospedale tranese ci sia stata una Confraternita, lo si deduce da un documento del 1577 , che cita esplicitamente la "Confraternita di S. Maria dei Bianchi" per dei lasciti ricevuti.
Il nome della Confraternita di San Vito compare, comunque, nel 1639, durante una delle visite pastorali dell'Arcivescovo Tommaso Ancora e in un altro documento del 1708, quale erede della Confraternita di Santa Maria de' Bianchi e riceve il Regio Assenso il 4 giugno 1791 .
La Congrega era composta da fratelli esercitanti l'arte dei marinai, ma si potevano aggregare "Novizi", senza limiti di numero, anche se il governo della Confraternita restava nelle mani dei trentatré più anziani e solo venendo a mancare uno di loro, veniva sostituito gradualmente dal più anziano. All'atto dell'iscrizione dovevano versare dieci carlini fino a vent'anni; da venti a trent'anni tanti tarì in più quanti erano gli anni e da trenta in su l'ammontare dell'offerta era fissata dalla Congrega. Inoltre, durante l'anno di noviziato, l'iscritto non godeva di nessun beneficio e versava un carlino al mese, mentre dopo l'anno, la quota era di cinque grana per tutta la vita.
Anche questa Confraternita eresse un Monte dei Morti per assolvere i suoi bisogni funerari, come risulta dallo stesso statuto. Oltre al motivo religioso, la Confraternita aveva cura della formazione "civica" dei fratelli, abituandoli al rispetto delle norme statutarie ed al senso della responsabilità, educandoli a convivere nella Confraternita. La penalità per chi non si atteneva ad un comportamento corretto, andava dalla sospensione per sei mesi fino all'espulsione.
La Confraternita risiedette fino al 1827 nella chiesa di San Vito (ex Santa Maria de' Bianchi), che sorgeva dove oggi vi è il boschetto della Villa Comunale, poi passò nella chiesa di San Domenico, nella chiesa del Carmine e, nei primi del 900, definitivamente nella chiesa di Santa Chiara.
La Congrega partecipa alla processione del Venerdì Santo portando l'immagine di Cristo nell'orto . La Confraternita ha sede nella Chiesa di Santa Chiara, il santo festeggiato è San Vito il quindici giugno. La sua divisa si compone di "sacco", "buffa" e "guanti" bianchi; "cingolo" e "nastro" rosso, la "mozzetta" è rossa con medaglione in metallo. Il gonfalone è costituito da un drappo rosso dove è inserita l'immagine di San Vito, e in cima le piume sono bianche e rosse (Daniela Di Pinto).
La Congrega era composta da fratelli esercitanti l'arte dei marinai, ma si potevano aggregare "Novizi", senza limiti di numero, anche se il governo della Confraternita restava nelle mani dei trentatré più anziani e solo venendo a mancare uno di loro, veniva sostituito gradualmente dal più anziano. All'atto dell'iscrizione dovevano versare dieci carlini fino a vent'anni; da venti a trent'anni tanti tarì in più quanti erano gli anni e da trenta in su l'ammontare dell'offerta era fissata dalla Congrega. Inoltre, durante l'anno di noviziato, l'iscritto non godeva di nessun beneficio e versava un carlino al mese, mentre dopo l'anno, la quota era di cinque grana per tutta la vita.
Anche questa Confraternita eresse un Monte dei Morti per assolvere i suoi bisogni funerari, come risulta dallo stesso statuto. Oltre al motivo religioso, la Confraternita aveva cura della formazione "civica" dei fratelli, abituandoli al rispetto delle norme statutarie ed al senso della responsabilità, educandoli a convivere nella Confraternita. La penalità per chi non si atteneva ad un comportamento corretto, andava dalla sospensione per sei mesi fino all'espulsione.
La Confraternita risiedette fino al 1827 nella chiesa di San Vito (ex Santa Maria de' Bianchi), che sorgeva dove oggi vi è il boschetto della Villa Comunale, poi passò nella chiesa di San Domenico, nella chiesa del Carmine e, nei primi del 900, definitivamente nella chiesa di Santa Chiara.
La Congrega partecipa alla processione del Venerdì Santo portando l'immagine di Cristo nell'orto . La Confraternita ha sede nella Chiesa di Santa Chiara, il santo festeggiato è San Vito il quindici giugno. La sua divisa si compone di "sacco", "buffa" e "guanti" bianchi; "cingolo" e "nastro" rosso, la "mozzetta" è rossa con medaglione in metallo. Il gonfalone è costituito da un drappo rosso dove è inserita l'immagine di San Vito, e in cima le piume sono bianche e rosse (Daniela Di Pinto).
Condizione giuridica:
enti di culto (1639 - )
Profili istituzionali collegati:
Confraternita, sec. XII -
Per saperne di più:
Confraternita di San Vito di Trani (BAT)
Complessi archivistici prodotti:
Confraternita di San Vito di Trani (fondo)
Bibliografia:
E. BATTAGLIA, 'Fra le tradizioni pasquali', in «Il Tranesiere», n. 4, XXI 1979., 9 - 10
AA. VV., 'Gli statuti confraternali in Terra di Bari (XVI-XIX)', a cura di LIANA BERTOLDI LENOCI, Edizioni Pugliesi, in corso di allestimento.
P. DI BIASE, "Appunti per una storia delle Confraternite della Diocesi di Trani (secoli XV-XVIII)", in Le confraternite, segno e presenza cristiana nella Chiesa locale, Roma, Vivere in, 1989., 119 - 134
P. DI BIASE, "Aspetti evolutivi ed involutivi della realtà confraternale della diocesi di Trani nel Settecento", in Le Confraternite Pugliesi in Età Moderna. Atti del Seminario internazionale di studi, 28-29-30 aprile 1988, a cura di LIANA BERTOLDI LENOCI, Fasano, Schena, 1988., 304 - 331
P. DI BIASE, "Le confraternite laicali della Diocesi di Trani in età moderna", in Uomini e donne nella Chiesa. Atti della VII Primavera di Santa Chiara 1987, a cura di SALVATORE SPERA, Roma, Vivere in, 1988., 155 - 244
P. DI BIASE, 'Vescovi, clero e popolo: lineamenti di storia dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie', Barletta, Rotas, 2013.
P. DI BIASE, 'Vescovi, disciplinamento religioso e controllo sociale: l'Arcidiocesi di Trani fra Medioevo ed età moderna: atti del Convegno di studi', Trinitapoli, Auditorium dell'Assunta, 20-21 ottobre 2000, Bari Società di storia patria per la Puglia, 2001.
'Le confraternite: segno e presenza cristiana nella Chiesa locale, Atti del primo congresso delle confraternite', Trani 26-28-29 marzo 1987, Roma, Vivere in, 1989.
G. MAIORANO, 'Il Consiglio Generale degli ospizi di Terra di Bari: fonte per la storia delle Confraternite', in 'Le Confraternite Pugliesi in Età Moderna 2. Atti del Seminario internazionale di studi, 27-28-29 aprile 1989', a cura di L. BERTOLDI LENOCI, Fasano, Schena, 1990, pp. 237-311.
F. PAGANO, 'Le confraternite tranesi, storia e colore delle tradizioni popolari', Trani, 2000.
F. SPACCUCCI, 'Prodromi assicurativi nelle antiche confraternite di Trani', Napoli, Laurenziana, 1978.
'Statuto per le confraternite delle Archidiocesi di Trani e Barletta e della Diocesi di Bisceglie', Trani, Paganelli, 1940.
Redazione e revisione:
Di Pinto Daniela, 2010/04/15, prima redazione
Mincuzzi Antonella, 2019/10/16, revisione
Paparella Angelica, 2019/03/22, integrazione successiva
Pontrelli Maria Pia, 2019/03/22, supervisione della scheda