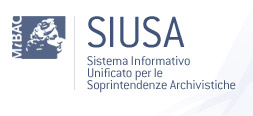Estremi cronologici: 1950 - 1995
Consistenza: Il materiale documentario è costituito da circa 575 rotoli di disegni e 88 scatole. Due di queste, di cartone bianco, hanno la dimensione 31x23x22 cm; tutte le altre, di cartone marrone, sono di tre diverse misure: 38x35x38 cm; 29x36x35 cm; 45x32x46 cm.
I rotoli sono conservati per lo più in tubi di plastica o di cartone, dal diametro compreso tra 5 e 10 cm. Non sempre però i disegni dell’architetto sono contenuti al loro interno; in almeno un centinaio di casi, i rotoli sono avvolti su se stessi senza alcuna protezione.
Le condizioni del materiale, in tutte quante le situazioni, sono discrete.
Storia archivistica: Alla sua morte Gabriele Manfredi ha devoluto al FAI - Fondo Ambiente Italiano, di cui condivideva idee e iniziative, alcuni suoi beni e in particolare il proprio patrimonio bibliografico e archivistico conservato nello studio di Torino in via Alfonso Bonafous, 8. Grazie all’interessamento dell’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica e del professor Giuseppe De Luca del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, il fondo è stato donato dal FAI alla Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura in data 14 giugno 2016.
Il materiale è ancora da riordinare.
Descrizione: I disegni conservati nel fondo Manfredi sono identificabili grazie a delle etichette (apposte sul coperchio dei tubi) che seguono uno schema ricorrente: sigla numerica identificativa dell’intervento contenuto all’interno, accompagnata da una sintetica descrizione degli elaborati. A eccezione di pochissimi casi, i tubi contengono rotoli di disegni che si riferiscono a un solo progetto, quello che è coerentemente riportato nell’adesivo apposto sul coperchio e richiamato nel cartiglio interno; pertanto i contenuti dei tubi sono univocamente identificati dalle sigle numeriche, che ammontano in totale a circa un centinaio. Per esempio, il numero 3015 si riferisce alla ristrutturazione di un edificio scolastico nel Comune di Pontecurone (Alessandria), il 2081 al Piano regolatore di Tortona, il 3056 al riordino delle Facoltà Umanistiche dell’Università del capoluogo piemontese e così via. Talora la medesima sigla si presenta più di una volta poiché uno stesso intervento può interessare più rotoli a causa di un elevato numero di disegni o perché il progetto può essere stato sviluppato da Manfredi in momenti diversi. È il caso dell’etichetta 3030, riferita all’Interporto di Torino, che si ripete molto spesso poiché numerosi sono i tubi dedicati a questo intervento e ai vari lavori a esso collegati, come la realizzazione di strade, i collegamenti infrastrutturali, la costruzione di padiglioni e servizi.
Le date, che solo raramente sono riportate sul tubo, si trovano direttamente sui disegni in cartigli molto dettagliati, scritti generalmente a mano e che seguono tutti il medesimo schema. Vi sono riportati i nomi dei collaboratori (spesso gli ingegneri Alberto Todros o Vittorio Cappato), l’indirizzo dello studio, la sigla numerica del progetto (che si ripresenta sul coperchio del tubo), la data dell’intervento, il committente, l’oggetto del disegno e la numerazione progressiva della tavola. Tutti i disegni raffigurano elaborati tecnici: impianti, strutture, progetti definitivi ed esecutivi, rilievi in pianta, prospetto, sezione. Sono eseguiti quasi sempre a china (solo in pochissimi casi a matita) con spessori diversi e poche cancellature; talvolta ci sono dei retini applicati. Spesso le tavole presentano accanto ai disegni dei trafiletti con specifiche tecniche, tabelle, i nomi delle strade e didascalie varie. Non ci sono quasi mai schizzi preparatori (a parte quelli per il riordino delle Facoltà Umanistiche) o bozze, mentre si trovano in qualche caso mappe, carte geografiche e stampe con appunti.
I supporti delle rappresentazioni grafiche sono vari: spolvero, lucido (soprattutto), radex ed eliocopie. In misura minore sono presenti la carta e le foto aeree. I lucidi sono spesso profilati con del nastro di protezione. Le tipologie di intervento, per una committenza sia pubblica che privata, sono molto varie: uffici, infrastrutture, piani regolatori, edifici destinati a servizi, lottizzazioni, grandi complessi condominiali, case unifamiliari. Fra i progetti di Manfredi che ci sono pervenuti non mancano quelli più famosi, come il già citato Interporto di Orbassano-Torino della seconda metà degli anni Ottanta (un centro intermodale merci dell’area torinese di 3.000.000 di mq) o il Centro Piero della Francesca, nel capoluogo piemontese, un complesso edilizio costituito da sette fabbricati realizzato alla fine degli anni Settanta e destinato al terziario avanzato. Molti sono i rotoli che riguardano costruzioni per civile abitazione progettati prevalentemente in Piemonte o in Liguria per una committenza privata, come per esempio una villa a Pecetto Torinese (1962) o un edificio in Corso Belgio (Torino, 1966); altrettanto numerosi quelli relativi a lottizzazioni per fabbricati civili e a piani regolatori di alcuni comuni piemontesi, quali Tortona (Alessandria) nel 1990, Givoletto (Torino) nel 1988 e altri. Per quanto riguarda le 88 scatole, queste sono quasi tutte contrassegnate da un’annotazione a pennarello “ARCH. MANFREDI”. Quelle marroni hanno un numero arabo progressivo che va, con vari salti e lacune, da 3 a 96; sulle due scatole bianche, non numerate, sono state apposte in questa sede le sigle 1B e 2B. Talvolta è annotato anche un sintetico appunto circa il genere di contenuto: “CASS.”, “DIAPO”, “FOTO”. Le scatole contrassegnate dalle etichette “DIAPO” e “FOTO” conservano quasi sempre materiale esclusivamente di questo tipo – diapositive e stampe fotografiche – prevalentemente riferito a riproduzioni di disegni. Invece le scatole contraddistinte dall’etichetta “CASS.” contengono fascicoli estratti apparentemente da una cassettiera. Si tratta di materiale eterogeneo e di varia natura che si riferisce a più di un intervento; sono presenti documenti relativi a progetti, tavole grafiche, corrispondenza, pratiche amministrative, relazioni, fatture e parcelle, pratiche edilizie, contabilità, microfilm. Altre scatole invece racchiudono tavole o faldoni con la documentazione di un progetto ben preciso; in tal caso questo materiale è contrassegnato con la medesima sigla numerica identificativa dell’intervento che si ritrova sul coperchio dei tubi. Altre volte il contenuto è rappresentato da libri e riviste di architettura («Casabella», «Vitrum», «Torino»). In particolare, in una delle due scatole bianche ci sono libri che spaziano dalla letteratura, italiana e straniera, alla musica, al teatro, con alcuni volumi che recano in contro copertina il timbro della sorella: «Luisa King Manfredi “Angelica” 1906-1990».
I supporti delle rappresentazioni grafiche sono vari: spolvero, lucido (soprattutto), radex ed eliocopie. In misura minore sono presenti la carta e le foto aeree. I lucidi sono spesso profilati con del nastro di protezione. Le tipologie di intervento, per una committenza sia pubblica che privata, sono molto varie: uffici, infrastrutture, piani regolatori, edifici destinati a servizi, lottizzazioni, grandi complessi condominiali, case unifamiliari. Fra i progetti di Manfredi che ci sono pervenuti non mancano quelli più famosi, come il già citato Interporto di Orbassano-Torino della seconda metà degli anni Ottanta (un centro intermodale merci dell’area torinese di 3.000.000 di mq) o il Centro Piero della Francesca, nel capoluogo piemontese, un complesso edilizio costituito da sette fabbricati realizzato alla fine degli anni Settanta e destinato al terziario avanzato. Molti sono i rotoli che riguardano costruzioni per civile abitazione progettati prevalentemente in Piemonte o in Liguria per una committenza privata, come per esempio una villa a Pecetto Torinese (1962) o un edificio in Corso Belgio (Torino, 1966); altrettanto numerosi quelli relativi a lottizzazioni per fabbricati civili e a piani regolatori di alcuni comuni piemontesi, quali Tortona (Alessandria) nel 1990, Givoletto (Torino) nel 1988 e altri. Per quanto riguarda le 88 scatole, queste sono quasi tutte contrassegnate da un’annotazione a pennarello “ARCH. MANFREDI”. Quelle marroni hanno un numero arabo progressivo che va, con vari salti e lacune, da 3 a 96; sulle due scatole bianche, non numerate, sono state apposte in questa sede le sigle 1B e 2B. Talvolta è annotato anche un sintetico appunto circa il genere di contenuto: “CASS.”, “DIAPO”, “FOTO”. Le scatole contrassegnate dalle etichette “DIAPO” e “FOTO” conservano quasi sempre materiale esclusivamente di questo tipo – diapositive e stampe fotografiche – prevalentemente riferito a riproduzioni di disegni. Invece le scatole contraddistinte dall’etichetta “CASS.” contengono fascicoli estratti apparentemente da una cassettiera. Si tratta di materiale eterogeneo e di varia natura che si riferisce a più di un intervento; sono presenti documenti relativi a progetti, tavole grafiche, corrispondenza, pratiche amministrative, relazioni, fatture e parcelle, pratiche edilizie, contabilità, microfilm. Altre scatole invece racchiudono tavole o faldoni con la documentazione di un progetto ben preciso; in tal caso questo materiale è contrassegnato con la medesima sigla numerica identificativa dell’intervento che si ritrova sul coperchio dei tubi. Altre volte il contenuto è rappresentato da libri e riviste di architettura («Casabella», «Vitrum», «Torino»). In particolare, in una delle due scatole bianche ci sono libri che spaziano dalla letteratura, italiana e straniera, alla musica, al teatro, con alcuni volumi che recano in contro copertina il timbro della sorella: «Luisa King Manfredi “Angelica” 1906-1990».
Documentazione collegata:
Manfredi ha compiuto una donazione, intestandola alla sorella Luisa Manfredi King (1906-1990), con legato testamentario in favore della Biblioteca dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, con sede a Saluzzo (Cuneo), pianista di talento formatasi a Milano e a Parigi tra le due guerre. Militante comunista fin dagli anni Trenta, Luisa Manfredi ebbe un ruolo primario nella costituzione e nell’azione delle brigate Garibaldi in Bassa Valtellina, con il nome di battaglia di “Manuela”. Colpita da congelamento alle mani e ai piedi nell’inverno 1944, venne trasferita a Torino dove collaborò strettamente, con lo pseudonimo di “Angelica”, con il fratello Gabriele e con Giorgio Amendola fino alla liberazione del 26 aprile 1945. Costretta ad abbandonare la carriera pianistica per i danni fisici subiti, nel Dopoguerra si trasferì a Londra dove sposò nel 1950 lo scrittore Robin Raleigh King (scomparso pochi anni dopo) e dove si affermò come traduttrice di testi letterari e tecnici e come interprete simultanea. Tornata a Torino, vi morirà nel 1990. Un suo fondo librario e archivistico. Conservata presso: Istituto Gramsci di Torino (Consulta la descrizione online)
Il patrimonio librario, conserva invece volumi appartenuti prevalentemente all’ingegnere Gabriele Manfredi. È pervenuto nel luglio 2016, pochi mesi dopo la sua morte, ed è costituito da oltre 10.000 unità bibliografiche che riguardano i più disparati settori della cultura, con preminenza di opere pertinenti l’architettura e l’urbanistica (oltre 2.000, inclusi periodici nazionali ed internazionali). Sono presenti altresì sezioni relative alla storia dell’arte (ca. 1.550 volumi), narrativa e poesia (ca. 1.850), testi teatrali (ca. 330), Venezia e Repubblica veneta (ca. 480), storia (ca. 500), filosofia (350), sociologia e politica (ca. 460), storia della musica (ca. 230), scienze (ca. 350), enciclopedie e dizionari (ca. 548), storia delle religioni (350), giurisprudenza (200), città di Torino (280), viaggi e turismo (520), varia (280). Al fondo librario si aggiunge la collezione discografica che consiste di circa 2.100 dischi in vinile, relativi in prevalenza alla storia musicale dal XIV al XVIII secolo: gli autori più amati da Manfredi sono stati Vivaldi, Telemann, Bach, Haendel, Haydn e Mozart. Conservata presso: Istituto per i Beni Musicali in Piemonte (Consulta la descrizione online)
Il sodalizio professionale fra Manfredi, Berlanda e Todros si tradusse nella compartecipazione a progetti, piani regolatori e concorsi, Di quello, risultato vincitore, relativo al progetto INA-Casa per la provincia di Alessandria del 1951, si conserva documentazione nel Fondo Franco Berlanda. Conservata presso: Biblioteca “Roberto Gabetti” del Politecnico di Torino (Consulta la descrizione online)
Per lascito testamentario sono conservati gli scritti e i disegni dell’architetto torinese Enzo Venturelli, L’inventario è stato redatto nel 2003 sulla base di elenchi già esistenti all’atto del versamento e curati dal geometra Nazario Droghetti, collaboratore dell’architetto. Nella documentazione – il corpo del lascito è costituito da 168 buste e 16 cartelle di disegni – è presente anche materiale relativo allo zoo di Torino e in particolare al progetto di Venturelli dell’originalissimo edificio dell’acquario - rettilario, inaugurato nel 1960. Conservata presso: Archivio di Stato, Torino (Consulta la descrizione online)
Archivio della Società Molinar, dalla Collezione Terni, Sull’intervento relativo allo zoo, alla cui progettazione Manfredi iniziò a lavorare alla fine degli anni Quaranta su committenza della Società Molinar, importatrice di animali esotici (cui subentrò la ditta Terni dopo la morte dei titolari), nel libro di Gabriele Maschietti, Marina Muti, Pietro Passerin D'Entreves intitolato "Giardini zoologici. Vicende storico-politiche degli zoo torinesi (1851-1989)" sono pubblicate foto di plastici, immagini storiche e disegni tratti dall’Archivio della Società Molinar. Conservata presso: Archivio Storico della Città di Torino e dall’Archivio Edilizio
La documentazione è stata prodotta da:
Manfredi Gabriele
La documentazione è conservata da:
Università degli Studi di Firenze. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Architettura (1999 - )
Redazione e revisione:
Nocentini Monica, 2021/07, revisione
Ricci Chiara, 2020/11, prima redazione
Modalità di consultazione:
L’archivio è consultabile su appuntamento.