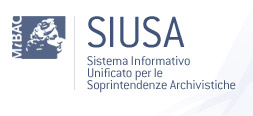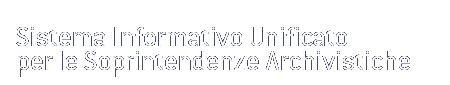scrittrice
Intestazioni:
Fantastici Rosellini, Massimina, scrittrice (Firenze 1789 - Lucca 1859), SIUSA
Massimina Fantastici nasce Firenze l'8 giugno 1789 da Giovanni Fantastici, gioielliere, e Fortunata Sulgher, livornese, poetessa nota in Arcadia col nome di Temira Parasside. Casa Fantastici è un ambiente colto e intellettualmente stimolante, luogo di incontri di letterati, tra cui Vittorio Alfieri, che apprezzava i versi di Fortunata. A undici anni Massimina entra nel conservatorio di S. Agata a Firenze A sedici anni sposa Luigi Rosellini, patrizio pesciatino, segretario di Maria Luigia di Borbone, regina d’Etruria, dal quale ha quattro figlie e un figlio, morto in giovane età. Scrive in questo periodo le odi "Per la bellissima giovane pistoiese" (dedicata ad Alessandra Rospigliosi) e "In morte di Labindo" (il poeta Giovanni Fantoni), pubblicate a Parma nel 1809. Nel 1810 comincia il poemetto "Cefalo e Procri" (pubblicato a Rovigo nel 1835), breve componimento di ispirazione classica sull’amore tra i due protagonisti, letto, apprezzata e postillata dal Foscolo. Del 1812 sono i versi pubblicati nello stesso anno a Pisa nella raccolta "Per la Venere italica scolpita da Antonio Canova", comprendente testi di altri undici poeti del neoclassicismo toscano. Attiva nella vita letteraria fiorentina, iscritta a molte accademie (Belle Arti di Firenze, Accademia Pistoiese, Accademia dei Filmati di Lucca, Arcadia e Accademia Tiberina), frequenta il salotto di Maria Luisa Stolberg contessa d’Albany amica di Ugo Foscolo. Si occupa dell’educazione delle figlie e dedica loro cinque commedie pedagogiche, divenute sette nella seconda edizione del volume "Commedie pei fanciulli". Il libro ha successo e cinque edizioni in sette anni (quella di Firenze del 1838 comprende
anche scritti educativi) e guadagna a Massimina la fama di educatrice. Seguono nel 1837 le "Letture pei fanciulli dai quattro ai sedici anni" e le "Commedie per l’adolescenza", commedie brevi rivolte ai giovani in cui Massimina riprende e volgarizza idee ispirate al cattolicesimo liberale e al pensiero pedagogico spiritualista dell’inizio dell'800, promuovendo un tipo di educazione che assecondie lo sviluppo naturale dell’individuo nel rispetto della sua libertà, e mantenga la centralità della religione e della cultura in tutte le classi sociali. Nel 1838 scrive la tragedia "I Pargi", sui fatti di Parga cantati anche da Berchet. Nel 1843 pubblica la sua opera più famosa, il poema in ottave "Amerigo", iniziato nel 1810 e lodato da Silvio Pellico, nel quale narra in venti canti l’impresa di Vespucci, in linea con la la tendenza a coniugare genere classico e tema di attualità, di gran moda nella prima metà dell’Ottocento.
Nel 1846 ottiene successo con il dramma "Il compare", dove racconta la seduzione di una contadina da parte di un conte, e che pubblica con lo pseudonimo Attilio Trotti. Nello stesso anno, perso il marito, si trasferisce a Pisa e rinuncia al suo impegno decennale di ispettrice di asili infantili. La serie degli scritti didattici è conclusa dal racconto "Guglielmo Wismar o il fanciullo istruito ne’ principali riti cattolici", pubblicato a Firenze nel 1853 per illustrare i riti della religione cattolica. Muore a Lucca il 24 gennaio 1859.
Nel 1846 ottiene successo con il dramma "Il compare", dove racconta la seduzione di una contadina da parte di un conte, e che pubblica con lo pseudonimo Attilio Trotti. Nello stesso anno, perso il marito, si trasferisce a Pisa e rinuncia al suo impegno decennale di ispettrice di asili infantili. La serie degli scritti didattici è conclusa dal racconto "Guglielmo Wismar o il fanciullo istruito ne’ principali riti cattolici", pubblicato a Firenze nel 1853 per illustrare i riti della religione cattolica. Muore a Lucca il 24 gennaio 1859.
Complessi archivistici prodotti:
Fantastici Rosellini Massimina (fondo)
Bibliografia:
Bandini Buti, Maria, "Poetesse e scrittrici", Roma, Istituto Editoriale Italiano, 1941-42, I, pp. 254- 255
Mazzoni Guido, "L’Ottocento", in "Storia letteraria d’Italia", Milano, Vallardi, 1973, I, pp. 381 ss.; II pp. 65, 82, 393
Redazione e revisione:
Bettio Elisabetta, 2011 ago. 9, prima redazione
Capannelli Emilio, revisione