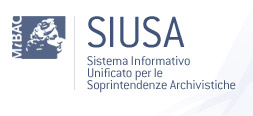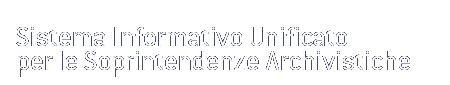Artista: pittore
Artista: scenografo
Headings:
Vagnetti, Gianni, artista: pittore, scenografo, (Firenze 1898 - Firenze 1956), SIUSA
La pittura di Vagnetti è stata avvicinata (ed è un giudizio che suo malgrado lo ha sempre accompagnato) a immagini e ambientazioni crepuscolari, a un mondo di cose e persone (come le malinconiche figure femminili ritratte nella serie delle educande) che non stonerebbero in una "stampa" palazzeschiana (non occasionali sono le litografie eseguite per l'edizione delle "Stampe dell'Ottocento" uscita nel 1942 per i tipi dei Cento amici del libro) e Emilio Cecchi ha parlato (1943) di "sensualità quasi gozzaniana". Per lui è stata usata anche la definizione di "pittura borghese" (Salvini, 1958) a delimitare un preciso retroterra culturale. La voglia di aggiornamento - non accontentandosi di suggestioni municipali - lo spinse comunque a documentarsi direttamente negli atelier parigini (il primo viaggio di studio in Francia è datato 1930) e se la lezione di riferimento rimane quella ottocentesca della "macchia", il mondo della tradizione e della misura tipicamente toscana di Vagnetti è tutt'altro che chiuso e scosso piuttosto da una "temperie non regionalistica dell'intelligenza" (Betocchi, 1966). La sua tavolozza, dove i tratti figurativi e la volontà didascalica si riconoscevano ancora nitidi (tra i maestri di riferimento, per le sue prime stagioni, si fanno i nomi di Armando Spadini e di Felice Carena), arriva quindi a scomporsi fino a giungere ad approdi definiti post-cubisti, il nome tutelare che la critica evoca per la stagione matura di Vagnetti è infatti quello di Braque. Ma al di là di ogni avanguardia e di suggestioni per le novità, il vero legame con l'arte di Oltralpe lo annodò con la scuola impressionista (e per la sua interpretazione di questo movimento si faccia riferimento alla preziosa monografia, intitolata per l'appunto "Impressionisti", che pubblicò alla fine della guerra). L'eredità più autentica che ci lascia rimane però sicuramente quella legata alle sue radici e alla serietà di un impegno tenacemente solitario svolto nel solco della tradizione. Proprio nell'ambito di un più generale ritorno all'ordine si può far rientrare la sua partecipazione, alla fine degli anni Venti, al "Gruppo Toscano Artisti d'Oggi" (poi rinominato "Gruppo Novecentesco Toscano") che sotto la guida teorica di Raffaello Franchi si propose come sponda toscana del movimento sarfattiano. Ma Vagnetti mantiene un difetto di intimismo e di eccessivo psicologismo che gli impediscono di raggiungere i volumi e la retorica di quel linguaggio. Nonostante le amicizie che ha coltivato tra i critici e gli artisti di apparato (Antonio Maraini e Cipriano Efisio Oppo su tutti), rapporti personali che gli assicurarono una presenza costante alle esposizioni ufficiali in Italia e all'estero (ha partecipato con continuità a numerose edizioni della Biennale di Venezia - dove nel 1932 allestì una sala personale, come una sala celebrativa gli fu dedicata nel 1956 per ricordarne la precoce scomparsa -, così come alla Quadriennale di Roma e alla Triennale di Milano), Vagnetti rimane lontano dal clima eroico-monumentale del fascismo, e nell'arco della sua parabola si può considerare come accessoria l'esecuzione, datata 1929, di un ritratto - per quanto apprezzato dal committente - di Mussolini.
A Firenze è stato tra i fondatori e presidente del "Premio del Fiorino", ha insegnato presso l'Istituto d'Arte di Porta Romana e dal 1940 presso l'Accademia di Belle Arti (nelle cui aule, interrompendo studi tecnici, aveva iniziato il suo tirocinio artistico dopo la prima lezione appresa dal padre, lo scultore Italo), dove l'anno successivo fu nominato titolare della cattedra di scenografia, di nuova istituzione. Oltre al lavoro di pittore in studio Vagnetti si è infatti distinto dal 1934 come scenografo e costumista e molto proficua è stata a tal proposito la collaborazione, datata dall'anno 1937, con il Maggio musicale fiorentino e il Teatro Comunale della sua città. Come pure da non ignorare è il suo lavoro nel campo delle arti grafiche: accanto alle citate "Stampe" di Palazzeschi (per lo scrittore fiorentino Vagnetti ha illustrato anche la sovracoperta del romanzo "I fratelli Cuccoli", Vallecchi, 1948) si segnalano le illustrazioni apparse a corredo di altri libri e riviste, tra cui un disegno pubblicato nella "Casa dei doganieri", il volumetto di Montale premio dell'"Antico Fattore" 1931 (Firenze, Vallecchi, 1932).
Generated archives:
Vagnetti Gianni (fondo)
Bibliography:
«Il Frontespizio», a. 10 (sett. 1938) n° 9: fascicolo dedicato a Vagnetti, con riproduzione di sue opere e un profilo critico del pittore (riproposto alle p. 157-158 di "Tendenze del Novecento: naturalezza come stile. L'idea dell'arte nelle pagine de «Il Frontespizio», 1937-1939", catalogo a cura di Marco Moretti, Pisa, Pacini, 2002).
Nino Bertocchi, "Gianni Vagnetti", Firenze, Vallecchi, 1943.
"Vagnetti", a cura di Raffaello Franchi, Firenze, Arnaud, 1947.
"Mostra retrospettiva di Gianni Vagnetti", con presentazione di Roberto Salvini, Firenze, Sansoni, 1958.
"Disegni di Gianni Vagnetti (1898-1956) esposti al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi", testo e catalogo di Antony De Witt, Firenze, Sansoni, 1960.
"Gianni Vagnetti", premessa di Carlo Ludovico Ragghianti, presentazione di Carlo Betocchi, Firenze, Nuovedizioni Vallecchi, 1966.
Luigi Cavallo, "Gianni Vagnetti", Milano, Edizione d'Arte Sant'Ambrogio, 1975.
"Gianni Vagnetti. Opere dal 1921 al 1956", mostra retrospettiva a cura di Corrado Marsan, Anghiari, 6 agosto-11 settembre 1988, Firenze, Arnaud, 1988.
"Gianni Vagnetti (1897-1956)", catalogo e schede a cura di Beatrice Buscaroli Fabbri, Bologna, Galleria Giordani, 1995.
"Quattro voci della pittura toscana del Novecento. Carena, Soffici, Rosai, Vagnetti", a cura di Luigi Cavallo, Firenze, Edizioni «Il Ponte», 1998.
Editing and review:
Capannelli Emilio, revisione
Desideri Fabio, 16 settembre 2010, prima redazione
Stamuli Maria Francesca, 2019/07/16, integrazione successiva