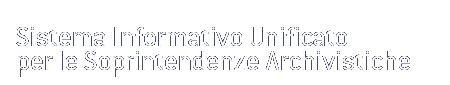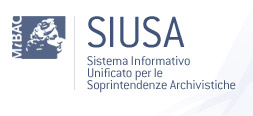Seat: Torino
Date of live: sec. XX inizio - sec. XX seconda metà
Headings:
Grandi motori, Torino, sec. XX inizio - sec. XX seconda metà, SIUSA
Nel quartiere torinese di Barriera di Milano, sorge nel 1884 l’Officina meccanica Michele Ansaldi, azienda costruttrice di macchine utensili, che impiega circa 300 operai altamente qualificati (in particolar modo aggiustatori meccanici e lavoratori specializzati). Nel marzo del 1905, Michele Ansaldi, spinto anche dalla Banca commerciale italiana (attorno alla quale ruotano le principali concentrazioni industriali della siderurgia italiana), sigla un’intesa con Agnelli che decreta la nascita della Fiat-Ansaldi. Il sodalizio ha però vita molto breve: fin dai primi mesi tra le due parti sorgono dissidi e dissapori che portano la Banca commerciale, in possesso di 2000 azioni della Fiat Ansaldi, a decidere di sintonizzare l’attività delle Officine Ansaldi alle cadenze Fiat, come unica strada percorribile per il rilancio della società. Così, nel gennaio del 1906 Michele Ansaldi si dimette dalla carica di consigliere delegato dell’omonima società e cede la sua quota alla Fiat che incorpora le Officine meccaniche Ansaldi. Questo atto è legato ad una precisa strategia di mercato assunta dall’azienda torinese che mira, attraverso procedimenti associativi, a legare alla propria orbita altre società. Una di queste è il cantiere navale San Giorgio di Muggiano, nel golfo di La Spezia, che, nel 1905, è assorbito dalla Fiat. Nasce così la Società Fiat San Giorgio, un insieme di officine, destinate a sviluppare la costruzione di torpediniere sommergibili, che prevede, a Torino, la produzione di motori e tubi di lancio, e nel cantiere ligure quella dello scafo e le operazioni di montaggio. Nel capoluogo piemontese, l’area ritenuta idonea ad ospitare questo nuovo tipo di lavorazioni è proprio quella delle vecchie officine della Fiat Ansaldi (trasformata nel frattempo nella Società automobili brevetti Fiat) le cui attrezzature e maestranze sono considerate dai vertici della Fiat adatte a supportare la costruzione dei motori marini. E’ quindi in questo complesso, che affacciava sul lato nord di via Cuneo e comprendeva un reparto di lavorazione meccanica, una fonderia e un modesto impianto di fucinatura, che la Fiat inizia la produzione dei primi motori navali, a benzina e, in via sperimentale, diesel. Allo scopo di testare i motori viene anche costruito all’interno dello stabilimento un locale adibito a sala prove dove lavorano un buon numero di addetti, predominando, nei primi anni di attività, i problemi della messa a punto su quelli tecnologici di lavorazione. Tra il 1911 e il 1913 il crescente sviluppo della produzione (iniziano ad essere fabbricati oltre ai motori per sommergibili anche quelli per le navi mercantili) rende necessario un ampliamento dell’edificio. Nel 1916 la Fiat San Giorgio è ceduta al gruppo genovese Ansaldo, e muta il nome in Ansaldo San Giorgio. Da questa data, fino al termine del conflitto mondiale, le esigenze dettate dalla guerra richiedono alle officine notevoli sforzi produttivi uniti ad una diversificazione delle lavorazioni: oltre a più di 100 motori diesel di varia potenza per sommergibili, i 4000 operai dell’Ansaldo San Giorgio fabbricano anche tubi di lancio per siluri, mine galleggianti e varie centinaia di motori di aviazione per velivoli militari. La smobilitazione della produzione di guerra, la riduzione della manodopera e il ritorno alla costruzione di motori non più per usi militari, ma mercantili, caratterizzano gli anni del primo dopoguerra, in cui, alla fabbricazione di dodici motori mercantili per sei navi dei cantieri Ansaldo, si aggiunge anche quella di motori diesel e di propulsori per macchine ad uso industriale. Nel 1923 lo stabilimento torinese della Ansaldo San Giorgio è riacquistato dalla Fiat: questo passaggio sancisce la nascita della sezione Grandi Motori, adibita, appunto, alla costruzione di motori diesel per qualsiasi applicazione ed in particolare per uso marino Tornato di proprietà della Fiat, il complesso di Barriera di Milano è soggetto ad un grandioso piano di rinnovamento che termina solo nel 1928 e che prevede la copertura totale di alcuni cortili, la soppressione degli impianti di fucinatura, l’ingrandimento di quelli adibiti alla lavorazione dei motori di media grandezza, la costruzione di una nuova fonderia (con la totale sostituzione di macchinari e fabbricati), di un nuovo capannone per il montaggio e la prova dei motori e di un grande fabbricato, destinato ad uso magazzino e deposito materiali lungo il Corso Vercelli, che porta a 37.000 metri quadrati la superficie sulla quale si estende lo stabilimento. Nel 1935, il notevole incremento della produzione (in parte, e cioè relativamente al reparto calderai ed al magazzino ricambi, decentrata in alcuni locali delle officine del Lingotto), che è oramai orientata verso molteplici direzioni, dalla costruzione di motori termici marini, industriali, ferroviari, alla produzione di macchine utensili, di fusioni di ghisa, di gruppi meccanici diversi, fino ad arrivare alle lavorazioni parziali per conto terzi, rende necessario, all’interno degli edifici di Via Cuneo un ulteriore ampliamento che si concretizza con la fabbricazione di una nuova struttura in cemento armato adatta a grandi macchine e provvista di due ali laterali a due piani adatte ad estendere la piccola lavorazione. Al termine del secondo conflitto mondiale si avviano le operazioni di ricostruzione che, nonostante i danni riportati durante le azioni di guerra, si presentano tutt’altro che difficili. La stessa cosa non può essere detta per quello che riguarda la produzione. Essa, infatti, dal massimo raggiunto nel primo periodo bellico, cala rapidamente, prima di iniziare, a partire dal 1948, una timida ripresa. Nel 1950, per rendere la fabbrica in grado di competere con la concorrenza estera, la Fiat decide di intraprendere un ulteriore progetto di ampliamento e di aggiornamento dei locali e dei mezzi di produzione. Questa decisione è senza dubbio facilitata dalla disponibilità dello spazio e dei fabbricati Fiat ubicati sul lato sud di Via Cuneo, dove sono sistemate le fonderie di ghisa e di alluminio della produzione automobilistica, che, nel 1950, sono trasferite nel complesso di Mirafiori.Il programma di rinnovamento è realizzato tra il 1951 e il 1954 e sostanzialmente prevede la costruzione di una nuova fonderia, una sistemazione più razionale degli impianti utilizzati per i trattamenti termici e per la colatura dei cuscinetti, la fabbricazione di un nuovo capannone nella struttura di Via Cigna dove trasferire la lavorazione di tornitura dei pezzi pesanti ed un generale rinnovamento del macchinario e dei servizi generali. Grazie a questi interventi l’azienda acquista una nuova capacità produttiva, sia sul lato qualitativo che su quello quantitativo e riesce a far fronte, tra il 1957 e il 1960, ad un incremento delle commesse nel campo dei grandi motori e in quello dei motori leggeri e veloci, iniziando anche nuovi tipi di lavorazione, come quello delle turbine a gas. Nei primi anni sessanta, la Grandi Motori sembra aver riacquistato lo splendore di un tempo: si estende su una superficie di 182.000 metri quadrati (dei quali 85.000 coperti), possiede un parco macchinario che comprende circa 1.050 macchine utensili e impiega circa 4.000 dipendenti occupati nella produzione di motori Diesel, turbine, macchine utensili, ricambi e lavorazioni per conto terzi. Nell’ottobre del 1966, nell’ambito del ridimensionamento della cantieristica previsto dal piano Cipe, Vittorio Valletta, presidente della Fiat, sigla con Giuseppe Petrilli, presidente dell’Iri, un accordo per la creazione della "società Grandi motori di Trieste", fabbrica destinata a raccogliere l’eredità della torinese Grandi Motori di Torino, della triestina Fabbrica Macchine di Sant’Andrea (Fmsa) e, in parte, della genovese Ansaldo.
Legal position:
privato
Type of creator:
ente economico/impresa
Creators:
Fiat, collegato
Generated archives:
Grandi motori (fondo)
Editing and review:
Anselmo Sara, 2010/07/13, prima redazione


- italiano | English

Colonna con sottomenu di navigazione
Creators
Custodians