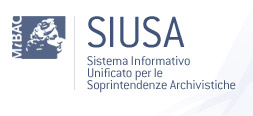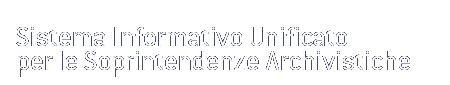Date di esistenza: sec. XIII -
Intestazioni:
Comune di Trapani, Trapani, sec. XIII -, SIUSA
Già dall’827, con l’arrivo degli Arabi a Trapani, la città aveva cominciato a godere di una crescita economica che portò ad una floridezza tale da spingere i trapanesi ad affiancare gli stessi Arabi quando Ruggero il Normanno, nel 1077, decise di assediare la città.
In realtà Ruggero di Altavilla, detto il Normanno, occupò Trapani ma con intelligenza e lungimiranza mantenne ai trapanesi e agli arabi presenti in città i privilegi goduti fino a quel momento, attraverso i quali continuare l’ascesa commerciale e industriale in corso.
Dalla fine del XIII secolo ha inizio la dominazione aragonese che portò pacificazione e prosperità, dopo il travagliato periodo angioino, aprendo così un’era di progresso economico, sociale, artistico, culturale che arricchì la città di nuovi rioni e nuovi palazzi.
In questo periodo verranno confermati i diritti acquisiti mentre si aggiungeranno nuovi privilegi.
La Biblioteca Fardelliana conserva un Textus Consuetudinum che, già nel 1858, Giuseppe Polizzi aveva reso noto con la pubblicazione delle Consuetudini, adottate da quelle di Messina nel 1331, successivamente confermate da re Martino. La stessa Biblioteca conserva anche un Regesto Poligrafo (secc. XIV-XV) che contiene, oltre alle Consuetudini, le Costituzioni o Capitoli regi. Il Museo Pepoli, inoltre, conserva il Libro rosso (Rollus) dei privilegi della città, ordinato nel 1601. Trapani, dunque, fu città demaniale governata da un Consiglio civico, a capo del quale già da epoca normanna troviamo il Baiulo coadiuvato da Giurati, che si riuniva più volte in un anno tanto in forma ordinaria quanto straordinaria. Il Consilium generale (straordinario) deliberava, tra l’altro, sull’imposizione di nuove gabelle, sull’alienazione del patrimonio comunale, sulla nomina dei sindaci, sull’approvazione di spese straordinarie. Il Consilium speciale (ordinario) deliberava su affari consueti, quali, tra l’altro, il salario degli ufficiali del comune, l’appalto delle gabelle civiche, l’emissione di bandi, l’elezione di cariche. Le cariche pubbliche avevano la durata di un anno (dal primo settembre al trentuno agosto) e le scelte erano fatte entro una lista di eleggibili detta mastra nobile o mastra giuratoria. Gli ufficiali responsabili dell’amministrazione erano dunque il capitano di giustizia, il prefetto, i giudici, il sindaco e i giurati.
Essi avevano il dovere di conservare il demanio dell’Universitas trapanese, accrescere il patrimonio della città attraverso l’imposizione di gabelle, far eseguire le prammatiche regie e contemporaneamente far osservare le consuetudini e i privilegi della città, acquisiti nei secoli. Il Capitano di giustizia, primo magistrato fin dalla dominazione normanna, che per privilegio di re Alfonso dal 1443 farà parte del Consiglio reale, amministrava la giustizia sia civile sia criminale e contro le sue sentenze si poteva ricorrere al Giudice di appello con sede a Palermo; dal XIV sec. però, con re Giacomo, Trapani ottenne il privilegio di avere tre giudici iurisperiti di cui uno di appellazione “perché il capitano giustiziere e i Giudici possano decidere le cause in Trapani senza estraersi dalla terra” (come si legge negli Annali della città). Questo fu per Trapani l’inizio della corte capitaniale che si occuperà in seguito delle sole cause criminali. Dal 1535 con Carlo V si comincia a notare la scissione tra giustizia civile e criminale, mentre dal 1585 gli Annali della città non citano più il giudice criminale come facente parte dell’amministrazione cittadina.
Il capitano di giustizia inoltre in quanto rappresentante dell’autorità regia vigilava sull’amministrazione cittadina.
Il Baiulo che nel 1464 prenderà il nome di Prefectus. Egli con i Giurati, che erano quattro per la città di Trapani, e i Giudici costituirono fin dall’origine la giunta amministrativa ma anche il tribunale di prima istanza. Dal 1611 si parla infatti di Prefetto come capo del magistrato civile o della Curia dei Giudici civili. Durante i consigli straordinari erano presenti tanto il Capitano, quale rappresentante regio, quanto il Prefetto che aveva diritto di parola e di voto subito dopo il Capitano.
Tornando ai Giurati dobbiamo dire che in periodo aragonese accrebbero maggiormente la loro importanza - come tutti gli altri ufficiali della città dovevano essere di vera e antica discendenza nobile - e nel 1443-1444 ottennero il titolo di regi consiglieri. Essi dovevano rendere conto della loro attività amministrativa alla Magna Curia Rationum che dal 1569 assunse il nome di Tribunale del Real Patrimonio, dal quale dipendeva un ufficiale regio incaricato di controllare, verificare e giudicare l’operato delle magistrature locali. Nel 1465-1466 i giurati fecero transuntare tutti “li privilegi della Patria incominciando da quelli del conte Ruggero il Normanno”. Il Libro rosso o Liber Privilegiorum venne tenuto nella cassa delle tre chiavi nella casa dei giurati che nel 1628 consolidarono il loro potere, sempre maggiore, acquistando dalla Regia Curia per 6500 scudi il privilegio di poter esercitare il foro del mero e misto imperio, cioè poter giudicare tanto le cause civili quanto quelle criminali. I giurati assunsero a Trapani il nome di Senatori nel 1644-1645. Con loro operavano, ma dovevano rendere loro conto della gestione amministrativa, ufficiali minori tra i quali i Deputati delle mete, i Deputati di sanità, i Rettori del Monte di Pietà, i Rettori dell’Annunziata. Infine altro ufficiale era il Sindaco, nominato in sede di consiglio straordinario, rappresentante e procuratore della città: veniva inviato quale ambasciatore al Parlamento Generale per tutelare gli interessi della città, vigilava sul rispetto dei privilegi accordati dai sovrani ed era il maestro notaro della gestione amministrativa. Dalla seconda metà del Cinquecento, ma come si evince dagli Annali già dal 1428, i Consigli si tennero nella chiesa di S. Agostino, definita dal viceré Guglielmo de Montanyes “duomo” dei giurati e con Carlo V addirittura “Chiesa Reale”. Da quel momento diventerà il luogo deputato per le riunioni più importanti dell’Universitas trapanese.
Nominata città da re Alfonso nel 1443-1444 secondo gli Annali o, come si legge in una lettera dello stesso archivio del Senato, ricevuto il privilegio di chiamarsi civitas nel 1589, Trapani, definita "invictissima" da re Ferdinando il Cattolico e "fidelissima" ai suoi sovrani da Carlo V, col declino della dominazione spagnola dovrà subire i malesseri, i disordini e le insurrezioni causate dal regime di assolutismo ad essa seguito. Il breve regno di Amedeo II di Aosta e il viceregno austriaco non ebbero esiti particolarmente felici. L’amministrazione sabauda, tra l’altro, ristrutturò il sistema fiscale locale mentre il viceregno austriaco proseguì nel riordino della finanza locale e nella maggiore autorità del potere centrale. Con l’avvento della dinastia borbonica poi si aggiunsero altri cambiamenti. Nel 1812 venne abolita la feudalità e i poteri locali liberati dalla tutela baronale poterono instaurare nuovi rapporti col sovrano e la sua amministrazione. Vennero formati nuovi consigli civici che però verranno sostituiti dal Decurionato a causa della riforma del 1817. Il Senato sarà quindi sostituito dal Decurionato i cui membri avranno compiti molto più limitati rispetto ai periodi precedenti, e gli stessi giurati non furono più eletti ma nominati dal Luogotenente del regno su richiesta dell’Intendente che gli proponeva una rosa di eleggibili. Con regio decreto del 1817 la Sicilia, divisa in tre valli a capo di uno dei quali era Trapani, viene ulteriormente suddivisa in 23 distretti inglobati subito dopo in sette Intendenze, cui erano subordinati tutti i comuni. Nel 1860 con l’arrivo dei Mille in Sicilia Trapani aderì alla dittatura garibaldina che fece tornare in uso termini quali pretore, senato e consiglio civico, alla fine di questa i primi due saranno sostituiti dagli ancora attuali sindaco e giunta. Negli anni Venti, come tutti i comuni italiani, fu retta da un magistrato unico, il Podestà. Dalla fine del secondo conflitto mondiale, poi, seguì il percorso democratico della nazione.
Il capitano di giustizia inoltre in quanto rappresentante dell’autorità regia vigilava sull’amministrazione cittadina.
Il Baiulo che nel 1464 prenderà il nome di Prefectus. Egli con i Giurati, che erano quattro per la città di Trapani, e i Giudici costituirono fin dall’origine la giunta amministrativa ma anche il tribunale di prima istanza. Dal 1611 si parla infatti di Prefetto come capo del magistrato civile o della Curia dei Giudici civili. Durante i consigli straordinari erano presenti tanto il Capitano, quale rappresentante regio, quanto il Prefetto che aveva diritto di parola e di voto subito dopo il Capitano.
Tornando ai Giurati dobbiamo dire che in periodo aragonese accrebbero maggiormente la loro importanza - come tutti gli altri ufficiali della città dovevano essere di vera e antica discendenza nobile - e nel 1443-1444 ottennero il titolo di regi consiglieri. Essi dovevano rendere conto della loro attività amministrativa alla Magna Curia Rationum che dal 1569 assunse il nome di Tribunale del Real Patrimonio, dal quale dipendeva un ufficiale regio incaricato di controllare, verificare e giudicare l’operato delle magistrature locali. Nel 1465-1466 i giurati fecero transuntare tutti “li privilegi della Patria incominciando da quelli del conte Ruggero il Normanno”. Il Libro rosso o Liber Privilegiorum venne tenuto nella cassa delle tre chiavi nella casa dei giurati che nel 1628 consolidarono il loro potere, sempre maggiore, acquistando dalla Regia Curia per 6500 scudi il privilegio di poter esercitare il foro del mero e misto imperio, cioè poter giudicare tanto le cause civili quanto quelle criminali. I giurati assunsero a Trapani il nome di Senatori nel 1644-1645. Con loro operavano, ma dovevano rendere loro conto della gestione amministrativa, ufficiali minori tra i quali i Deputati delle mete, i Deputati di sanità, i Rettori del Monte di Pietà, i Rettori dell’Annunziata. Infine altro ufficiale era il Sindaco, nominato in sede di consiglio straordinario, rappresentante e procuratore della città: veniva inviato quale ambasciatore al Parlamento Generale per tutelare gli interessi della città, vigilava sul rispetto dei privilegi accordati dai sovrani ed era il maestro notaro della gestione amministrativa. Dalla seconda metà del Cinquecento, ma come si evince dagli Annali già dal 1428, i Consigli si tennero nella chiesa di S. Agostino, definita dal viceré Guglielmo de Montanyes “duomo” dei giurati e con Carlo V addirittura “Chiesa Reale”. Da quel momento diventerà il luogo deputato per le riunioni più importanti dell’Universitas trapanese.
Nominata città da re Alfonso nel 1443-1444 secondo gli Annali o, come si legge in una lettera dello stesso archivio del Senato, ricevuto il privilegio di chiamarsi civitas nel 1589, Trapani, definita "invictissima" da re Ferdinando il Cattolico e "fidelissima" ai suoi sovrani da Carlo V, col declino della dominazione spagnola dovrà subire i malesseri, i disordini e le insurrezioni causate dal regime di assolutismo ad essa seguito. Il breve regno di Amedeo II di Aosta e il viceregno austriaco non ebbero esiti particolarmente felici. L’amministrazione sabauda, tra l’altro, ristrutturò il sistema fiscale locale mentre il viceregno austriaco proseguì nel riordino della finanza locale e nella maggiore autorità del potere centrale. Con l’avvento della dinastia borbonica poi si aggiunsero altri cambiamenti. Nel 1812 venne abolita la feudalità e i poteri locali liberati dalla tutela baronale poterono instaurare nuovi rapporti col sovrano e la sua amministrazione. Vennero formati nuovi consigli civici che però verranno sostituiti dal Decurionato a causa della riforma del 1817. Il Senato sarà quindi sostituito dal Decurionato i cui membri avranno compiti molto più limitati rispetto ai periodi precedenti, e gli stessi giurati non furono più eletti ma nominati dal Luogotenente del regno su richiesta dell’Intendente che gli proponeva una rosa di eleggibili. Con regio decreto del 1817 la Sicilia, divisa in tre valli a capo di uno dei quali era Trapani, viene ulteriormente suddivisa in 23 distretti inglobati subito dopo in sette Intendenze, cui erano subordinati tutti i comuni. Nel 1860 con l’arrivo dei Mille in Sicilia Trapani aderì alla dittatura garibaldina che fece tornare in uso termini quali pretore, senato e consiglio civico, alla fine di questa i primi due saranno sostituiti dagli ancora attuali sindaco e giunta. Negli anni Venti, come tutti i comuni italiani, fu retta da un magistrato unico, il Podestà. Dalla fine del secondo conflitto mondiale, poi, seguì il percorso democratico della nazione.
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale
Profili istituzionali collegati:
Comune, 1859 -
Comune (Regno delle due Sicilie), 1816 - 1860
Per saperne di più:
Comune di Trapani
Complessi archivistici prodotti:
Bandi e Consigli (serie)
Comune di Trapani (fondo)
Convento dell'Annunziata (serie)
Copialettere (serie)
Decurionato (serie)
Deputazione di Sanità (serie)
Deputazione frumentaria (serie)
Donazioni insinuate (serie)
Lettere (serie)
Mandata (serie)
Memoriali e Atti giudiziari (serie)
Miscellanea (serie)
Omnia Acta (serie)
Registri degli atti di cittadinanza (serie)
Registri degli atti di matrimonio (serie)
Registri degli atti di morte (serie)
Registri degli atti di nascita (serie)
Registri degli atti diversi (serie)
Soggiogazioni insinuate (serie)
Stato civile del comune di Trapani (fondo)
Bibliografia:
Pirri, "Sicilia Sacra", PALERMO, 1733
GIUSEPPE POLIZZI, Sull'antico Archivio del comune di Trapani. Lettere due d'un bibliofilo, Trapani 1870
GIUSEPPE POLIZZI, Su un Regesto poligrafo de' secoli XIV e XV presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani. Studj, Trapani 1873
ANTONINO CUTRERA, L'Archivio del Senato di Trapani dal secolo XIV al XVIII, Trapani 1917
CARMELO TRASSELLI, I Privilegi di Messina e di Trapani, Palermo 1949
VITO LA MANTIA, Testo antico delle consuetudini di Messina adottato in Trapani (1331), Palermo 1902
MARIO SERRAINO, Trapani Invittissima e Fedelissima, Trapani, Editore Corrao spa 1985
CARMELO TRASSELLI, Il Consolato dei messinesi e il Consolato del mare in Trapani, Palermo 1948
SALVATORE COSTANZA, L'archivio del Senato di Trapani conservato dalla Biblioteca Fardelliana, in "Trapani", XVIII, 1972
A. BAVIERA ALBANESE, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti, Roma, Società Italiana di Storia Patria, 1979
Redazione e revisione:
Vinci Rosalia - direzione lavori Romano, 2010/05/31, prima redazione