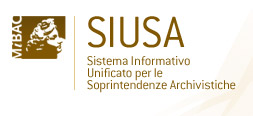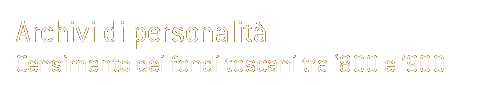Scrittore
Medico psichiatra
Intestazioni:
Tobino, Mario, scrittore, medico, psichiatra, (Viareggio 1910 - Agrigento 1991), SIUSA
Nasce a Viareggio da genitori di origini liguri, la famiglia è benestante ma il "figlio del farmacista" preferisce frequentare i coetanei figli di pescatori e artigiani che si ritrovano nella piazza davanti la farmacia del padre, il "piazzone" che rammenterà spesso nei testi rievocativi e nei ricordi di quegli anni giovanili. L'irrequietezza del giovane Tobino si sposa al suo rendimento scolastico: dopo aver iniziato il ginnasio a Viareggio e essere stato espulso dal liceo di Pistoia conosce la prima esperienza di segregazione (che anticipa in qualche senso i lunghi anni di autoreclusione vissuti da medico di manicomio: come se nella clausura - in questo caso volontaria - avesse scoperto un antidoto alla propria esuberanza) in un collegio di provincia (l'ambiente del collegio livornese di Collesalvetti rivivrà - con lo stratagemma, consueto per lo scrittore, dell'autobiografia mascherata - in "Una giornata con Dufenne"). Dopo una parentesi in un liceo di Massa, nel 1931 consegue la licenza liceale da privatista a Pisa, città dove si iscrive, seguendo le orme della professione paterna, alla facoltà di medicina. Contemporaneamente pubblica le prime prove letterarie: poesie, traduzioni, prose liriche, racconti e resoconti in forma documentaria che vedono la luce in testate periodiche, come quelle delle organizzazioni studentesche della GUF («Gioventù fascista», «Il Ventuno» ecc.) o nelle riviste della fronda giovanile, come «L'italiano» di Longanesi e «Il Selvaggio» di Maccari. Tra gli interlocutori con cui entra in contatto c'è anche Ezra Pound, che gli pubblica alcune traduzioni. Con l'a.a. 1933-34 si trasferisce all'Università di Bologna, una città che lo accoglie calorosamente e dove stringe importanti legami, per esempio quello abbracciato con un letterato del calibro di Giuseppe Raimondi o quelli nati con colleghi studenti come Mario Pasi e Aldo Cucchi, personaggi che (sotto mentite spoglie) torneranno in molte opere tobiniane (quella dell'autobiografia filtrata nella pagina, dell'esperienza vissuta e trasferita in rievocazione letteraria, rappresenterà per Tobino la chiave di volta di ogni tentativo di indagine: di una vicenda personale, di una 'comunità', di un evento storico). Nel 1934, per i tipi della rivista bergamasca «Cronache» (sulle cui pagine ha pubblicato vari pezzi), esce "Poesie", la sua prima raccolta di versi. Si laurea nel 1936 e sostiene l'esame di abilitazione a Perugia (il racconto dell'esame diventerà, anni dopo, "Bandiera nera" e tornerà in "Tre amici"). Dall'inizio del 1939 è in servizio all'ospedale psichiatrico di Ancona, dove rimarrà fino all'aprile dell'anno successivo, nello stesso anno pubblica a Bologna la sua seconda raccolta di poesie: "Amicizia". Nel 1940, con l'incarico di primario, è all'ospedale psichiatrico di Gorizia. Allo scoppio della guerra è richiamato alle armi e parte per la Libia, trascorrerà al fronte quasi 18 mesi come medico di campo. A fine 1941 è fatto rientrare in Italia per motivi di salute, trascorre la convalescenza lavorando come medico all'ospedale psichiatrico di Firenze. Dopo una nuova parentesi all'ospedale militare di Ancona, il 9 luglio 1942 prende servizio all'ospedale psichiatrico di Fregionaia a Maggiano (Lucca), dove eserciterà la professione per quasi quaranta anni. Nel corso dell'anno escono presso le Edizioni di Rivoluzione i versi di "Veleno e amore" (volume in cui trovano una prima collocazione le impressioni della guerra appena combattuta), "Il figlio del farmacista" (il primo testo in prosa dello scrittore) con i tipi delle edizioni di «Corrente» e - da Tumminelli - una raccolta di racconti di matrice viareggina dal titolo "La gelosia del marinaio". All'inizio del 1943 incontra Paola Olivetti, la compagna di una vita, che diventerà un personaggio di molte sue opere con il nome di Giovanna. Dal marzo al settembre 1944, avvalendosi della copertura che la sua professione gli concedeva, svolge azioni di collegamento, trasporto e pianificazione in molte operazioni della Resistenza versiliese: giudicherà questi mesi come intensi, entusiasmanti, carichi di aspettative, prendendone spunto per scrivere, dopo oltre dieci anni, "Il clandestino". Nel dopoguerra pubblica una raccolta di poesie ("'44-'48", Edizioni della Meridiana, 1949) e sconta continui rifiuti a "Bandiera nera", una nuova prova narrativa che alla fine viene anticipata nel 1950 presso le edizioni della rivista «Il costume politico letterario», mentre in volume vede la luce da Vallecchi l'anno successivo, in dittico con "L'angelo del Liponard". "Bandiera nera", al di là della velatura goliardica, rappresenta il primo tassello di un affresco storico su cui Tobino tornerà più volte. L'autentica matrice è infatti quella 'politica' e i protagonisti sono sempre gli stessi, Tobino e gli amici bolognesi Mario Pasi e Aldo Cucchi (velati sotto falso nome), mentre il soggetto è l'azione di accerchiamento e penetrazione capillare che l'apparato del regime aveva condotto sulle coscienze. Nel 1952 pubblica "Il deserto della Libia", romanzo-testimonianza dell'esperienza bellica vissuta tra il 1940 e il 1941. Prendendo come esempio questo libro si può precisare la tecnica di scrittura che tiene in piedi la maggior parte delle opere di Tobino: un abbandono alle sirene della memoria, tenuto vivo anche dalla stesura dei diari e alimentato per anni dalla pubblicazione sparsa di stralci, capitoli, articoli e poesie che fanno da battistrada al titolo in cantiere (a riprova di un lungo lavoro di preparazione che sta dietro il romanzo libico, nel 2011 è stato pubblicata, in appendice al testo maggiore, una versione inedita del "libro della Libia").
Quello sulla guerra di Libia è stato il primo titolo uscito da Einaudi, con la cui redazione Tobino ebbe rapporti particolarmente tempestosi, come del resto difficili sono stati quelli con tutti gli altri editori, compreso Mondadori che accoglierà Tobino nelle sue collane a partire dagli anni '60, senza però riuscire a ottenerne l'esclusiva. L'anno successivo escono "Le libere donne di Magliano" (Vallecchi), romanzo della consacrazione letteraria, cronaca della vita quotidiana in manicomio di cui il libro è una testimonianza in forma di diario intrecciato a ritratti clinici simili quasi, nella loro asciuttezza, a referti medici. "Asso di picche" è l'antologia di poesie - pubblicate a partire dal 1934 - data alle stampe sempre da Vallecchi nel 1955 (la poesia riceverà una sistemazione, nella storica collezione dello «Specchio», con l'edizione Mondadori che nel 1974 presenterà anche il seguito di "Veleno e amore secondo"). Nel 1956 ritorna da Einaudi con "La brace dei Biassoli", narrazione dove la linfa autobiografica palpita ancora di viva partecipazione per le vicende della famiglia materna. Altri titoli di questi anni rimarranno ai margini delle attenzioni dei lettori, alimentando i malumori e i risentimenti dello scrittore, per esempio le prose di viaggio (molto idiosincratiche) di "Due italiani a Parigi" (Vallecchi, 1954) e di "Passione per l'Italia" (Einaudi, 1958). Il grande successo, l'apertura verso un pubblico più vasto, la conquista delle attenzioni degli editori che se ne disputeranno la firma, arriverà con "Il clandestino", il primo titolo pubblicato con Mondadori e premio Strega nel 1962. Questo libro può essere considerato un altro capitolo del resoconto storico che, scandito in varie tappe (ma la dilazione non deve ingannare: la messa a fuoco di questi avvenimenti e il chiarimento del ruolo che ha avuto nel suo tempo, rappresentava un obiettivo che urgeva a Tobino forse più di ogni altra impellenza), lo scrittore ha abbozzato a partire dalla descrizione dell'atmosfera del Ventennio, per poi affrontare la guerra (organizzata o, appunto, clandestina) e i primi anni dopo la liberazione. E forse per la prima volta si giunge, in questo caso, a una forma più canonica di narrazione, a un romanzo popolare dal respiro manzoniano, e il successo si spiega anche con la perdita delle punte più indigeste di un congenito "primitivismo".
Tobino continua a procedere su vari piani: nel 1965 pubblica la raccolta "L'Alberta di Montenero" (Nuova Accademia editrice), nel 1966 escono i racconti di "Sulla spiaggia e di là dal molo" (Mondadori), il libro alimentato dall'amore verso la sua città natale; due anni dopo vede la luce "Una giornata con Dufenne" (unico titolo tobiniano nel catalogo Bompiani) in cui evoca (ma per un'ultima definitiva approssimazione dovremo aspettare "Tre amici") la drammatica vicenda di Mario Pasi (che in questo caso - rompendo la consueta tecnica del travestimento - compare palesemente con il suo nome). Nel 1972 esce "Per le antiche scale" (Mondadori), un nuovo grande successo, che continua la storia interrotta con le "libere donne di Magliano". Tobino è ormai uno scrittore celebrato (per "La bella degli specchi" riceve nel 1976 il premio Viareggio) e prolifico. Ma i conti in sospeso sono ancora aperti su vari fronti: nel 1974 prende di petto la sua più antica passione letteraria cimentandosi in un'atipica biografia di Dante ("Biondo era e bello"), "Il perduto amore" (1979) rielabora, in chiave romanzata, una storia d'amore vissuta ai tempi della guerra di Libia, con "La ladra" (1984) ritorna ancora una volta alla forma romanzo, nel 1987 concretizza un antico progetto teatrale pubblicando il copione de "La verità viene a galla", "Zita dei fiori" (1989) alterna storie locali (che, al di là di ogni campanile, accomunano in un unico abbraccio Lucca e Viareggio), casi clinici e ricordi (di nuovo) della guerra di Libia. Ma quello che torna prepotentemente di attualità è la discussione sulla malattia mentale e il bisogno di chiarire - una volta per tutte - quale sia stato il suo contributo quando è stato chiamato a partecipare alla vita collettiva (in particolare durante gli anni nevralgici della guerra e della liberazione). Il 1978 è l'anno della polemica contro quella che - una volta approvata - sarà chiamata Legge 180 o Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che l'aveva promossa. Tobino inaugurò il dibattito con il famoso articolo "Lasciateli in pace, è la loro casa" e poi con altri interventi, ma il suo appello rimase inascoltato. Le sue riflessioni sugli effetti della chiusura degli ospedali psichiatrici si sono coagulate in quel romanzo - in bilico tra diario e pamphlet - che è "Gli ultimi giorni di Magliano" (1982). Una identificazione (tra Tobino e la follia) così forte da mettere in sordina gli altri filoni della sua produzione (che possono essere individuati nelle storie di mare e nell'indagine sugli avvenimenti storici di cui è stato testimone) e che ha contribuito a farlo passare alla notorietà (lui stesso lo confessa) come "medico dei matti". Sull'argomento Tobino è ritornato un'ultima volta nel 1990 con "Il manicomio di Pechino", resoconto del biennio 1955-56 durante il quale ricoprì il ruolo di direttore dell'ospedale di Maggiano. Il romanzo che chiude i conti con il passato è invece "Tre amici" (1988), il punto di arrivo del filo rosso della sua passione politica, una sorta di autobiografia collettiva in cui racconta (sempre dietro lo stratagemma dei nomi occultati) la storia sua e degli amici di gioventù: Mario Pasi (martire della Resistenza nel 1945) e Aldo Cucchi, la cui parabola permette all'autore di spingersi fino agli inizi degli anni '50, quando l'amico fu protagonista, insieme a Valdo Magnani, di una drammatica denuncia (con conseguente espulsione dal partito) del supino asservimento del PCI al blocco sovietico. Postumo, nel 1992, è uscito "Una vacanza romana", libro dove - nel racconto "Le cartelle ritrovate" - sono state letteralmente trasposte le cartelle cliniche delle pazienti, del resto già orientate a una resa poetica.
Tobino continua a procedere su vari piani: nel 1965 pubblica la raccolta "L'Alberta di Montenero" (Nuova Accademia editrice), nel 1966 escono i racconti di "Sulla spiaggia e di là dal molo" (Mondadori), il libro alimentato dall'amore verso la sua città natale; due anni dopo vede la luce "Una giornata con Dufenne" (unico titolo tobiniano nel catalogo Bompiani) in cui evoca (ma per un'ultima definitiva approssimazione dovremo aspettare "Tre amici") la drammatica vicenda di Mario Pasi (che in questo caso - rompendo la consueta tecnica del travestimento - compare palesemente con il suo nome). Nel 1972 esce "Per le antiche scale" (Mondadori), un nuovo grande successo, che continua la storia interrotta con le "libere donne di Magliano". Tobino è ormai uno scrittore celebrato (per "La bella degli specchi" riceve nel 1976 il premio Viareggio) e prolifico. Ma i conti in sospeso sono ancora aperti su vari fronti: nel 1974 prende di petto la sua più antica passione letteraria cimentandosi in un'atipica biografia di Dante ("Biondo era e bello"), "Il perduto amore" (1979) rielabora, in chiave romanzata, una storia d'amore vissuta ai tempi della guerra di Libia, con "La ladra" (1984) ritorna ancora una volta alla forma romanzo, nel 1987 concretizza un antico progetto teatrale pubblicando il copione de "La verità viene a galla", "Zita dei fiori" (1989) alterna storie locali (che, al di là di ogni campanile, accomunano in un unico abbraccio Lucca e Viareggio), casi clinici e ricordi (di nuovo) della guerra di Libia. Ma quello che torna prepotentemente di attualità è la discussione sulla malattia mentale e il bisogno di chiarire - una volta per tutte - quale sia stato il suo contributo quando è stato chiamato a partecipare alla vita collettiva (in particolare durante gli anni nevralgici della guerra e della liberazione). Il 1978 è l'anno della polemica contro quella che - una volta approvata - sarà chiamata Legge 180 o Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che l'aveva promossa. Tobino inaugurò il dibattito con il famoso articolo "Lasciateli in pace, è la loro casa" e poi con altri interventi, ma il suo appello rimase inascoltato. Le sue riflessioni sugli effetti della chiusura degli ospedali psichiatrici si sono coagulate in quel romanzo - in bilico tra diario e pamphlet - che è "Gli ultimi giorni di Magliano" (1982). Una identificazione (tra Tobino e la follia) così forte da mettere in sordina gli altri filoni della sua produzione (che possono essere individuati nelle storie di mare e nell'indagine sugli avvenimenti storici di cui è stato testimone) e che ha contribuito a farlo passare alla notorietà (lui stesso lo confessa) come "medico dei matti". Sull'argomento Tobino è ritornato un'ultima volta nel 1990 con "Il manicomio di Pechino", resoconto del biennio 1955-56 durante il quale ricoprì il ruolo di direttore dell'ospedale di Maggiano. Il romanzo che chiude i conti con il passato è invece "Tre amici" (1988), il punto di arrivo del filo rosso della sua passione politica, una sorta di autobiografia collettiva in cui racconta (sempre dietro lo stratagemma dei nomi occultati) la storia sua e degli amici di gioventù: Mario Pasi (martire della Resistenza nel 1945) e Aldo Cucchi, la cui parabola permette all'autore di spingersi fino agli inizi degli anni '50, quando l'amico fu protagonista, insieme a Valdo Magnani, di una drammatica denuncia (con conseguente espulsione dal partito) del supino asservimento del PCI al blocco sovietico. Postumo, nel 1992, è uscito "Una vacanza romana", libro dove - nel racconto "Le cartelle ritrovate" - sono state letteralmente trasposte le cartelle cliniche delle pazienti, del resto già orientate a una resa poetica.
Per saperne di più:
Fondazione Mario Tobino
Complessi archivistici prodotti:
Tobino Mario (fondo)
Bibliografia:
Felice Del Beccaro, "Tobino", Firenze, La Nuova Italia, 1967, 2ª ed. 1973 con il titolo di "Mario Tobino" («il castoro»).
Massimo Grillandi, "Invito alla lettura di Mario Tobino", Milano, Mursia, 1975, 2ª ed. 1980.
"Mario Tobino, oggi", Viareggio, 9 marzo-31 marzo 2001, catalogo della mostra, Maschietto&Musolino, 2001. (Mario Tobino, oggi - Versione digitale della mostra allestita al Museo civico, Palazzo Paolina di Viareggio (9 - 31 marzo 2001).)
"Archivio multimediale Mario Tobino", 7 dvd a cura di Claire Soullier, Viareggio, Fantasy studio, 2007.
Mario Tobino, "Opere scelte", a cura di Paola Italia, con un saggio introduttivo di Giacomo Magrini e uno scritto di Eugenio Borgna, Milano, Mondadori, 2007 («i meridiani»).
"Le immagini del vivere. Scritture e figure di Mario Tobino", Viareggio, 15-31 gennaio 2010, mostra documentaria a cura di Marcello Ciccuto, Firenze, Polistampa, 2010.
Giuseppe Emiliano Bonura, Giacomo Contiero, Paola Italia, "Mario Tobino. Bibliografia testuale e critica (1931-2009)", Pontedera, Bibliografia e informazione, 2010.
"Il turbamento e la scrittura", a cura di Giulio Ferroni, Roma, Donzelli, 2010.
"La sabbia e il marmo. La Toscana di Mario Tobino", a cura di Giulio Ferroni, Roma, Donzelli, 2012.
"La biblioteca di Mario Tobino", a cura di Elena Tintori, introduzione di P. Italia, Pontedera, Bibliografia e informazione, 2012. (La biblioteca di Mario Tobino)
Redazione e revisione:
Capannelli Emilio, revisione
Desideri Fabio, 26 luglio 2011, rielaborazione
Desideri Fabio, 9 marzo 2023, integrazione successiva
Morotti Laura, 12 dicembre 2008, prima redazione