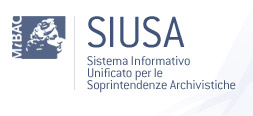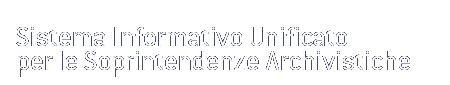Date di esistenza: 1860 - 1937
Intestazioni:
Congregazione di carità di Arcevia, Arcevia (Ancona), 1860 - 1937, SIUSA
Il Regio commissario generale straordinario nelle Province delle Marche, Lorenzo Valerio, dispose con decreto 24 ottobre 1860 n. 142 l'istituzione in ogni Comune di una Congregazione di carità per l'amministrazione di tutti i beni delle opere pie presenti sul territorio.
La legge nazionale n. 753 del 3 agosto 1862 sanciva l'istituzione delle Congregazioni di carità, organi di assistenza locale, costituiti da un presidente e da quattro o otto membri (a seconda che il comune avesse più o meno di diecimila abitanti) che dovevano rinnovarsi all'incirca ogni quattro anni, aventi il compito di "raccordare, a livello comunale, gli interventi non istituzionalizzati ai poveri, operando perciò in sintonia colle altre opere di beneficenza del luogo" e comprendendo quindi amministrativamente tutte le istituzioni della beneficenza preunitaria.
La Congregazione di carità di Arcevia riuniva le opere pie preunitarie: Ospedale; Scuola pia delle fanciulle; Ricovero di mendicità; Poveri di Palazzo; Monti frumentari di Nidastore, Loretello, San Pietro, Palazzo, Castiglioni, Avacelli, Caudino e Costa; Legati pii Mostarda e Ravagli; Monte di pietà; istituzioni dotalizie Salvucci; Zitelle povere di Castiglioni e Bernardino di Pietro di Piticchio; Scuola di calzoleria.
Dopo la creazione della "Commissione Correnti", costituita nel 1880 per indagare sulle opere pie del Regno, la riforma della beneficenza pubblica venne effettuata dalla legge Crispi n. 6972 del 17 luglio 1890. In seguito a tale riforma, la Congregazione di carità di Arcevia, il 5 settembre 1896, nella persona del Presidente Romani, "allo scopo di esplicare la beneficenza con vero e reale profitto dei poveri", emanava l'avviso con cui proponeva di raggruppare le diverse opere pie, "fondendole in due istituti Ospedale degli Infermi ed Orfanotrofio femminile, senza allontanarsi, per quanto possibile, dall'indole delle rispettive originarie fondazioni e lasciando a sé la Scuola di Calzoleria, che si chiamava Beneficenza Cesari, borsa di studio per arti e mestieri". Proponeva, pertanto, che a favore dell'Ospedale fossero riunite alle proprie sostanze le rendite delle seguenti opere pie: Poveri di Palazzo, un legato che distribuiva elemosine ai poveri di quel castello, Monti frumentari di Nidastore, Loretello, San Pietro, Palazzo, Castiglioni, Avacelli, Caudino e Costa, Legati pii Mostarda e Ravagli. In cambio di tali concentramenti, all'Ospedale venivano ammessi tutti gli infermi di ambo i sessi, poveri dimoranti nel Comune, o venivano sussidiati a domicilio, sia in medicinali che in denaro, quando particolari circostanze impedivano l'accesso all'Ospedale, o per distanza dalla loro residenza o per la natura della malattia, o "pel rigore della stagione".
Proponeva, poi, per l'Orfanotrofio femminile l'aggiunta ai beni appartenenti alla Scuola pia delle fanciulle delle rendite derivanti dalle Opere pie trasformate, cioè, Monte di Pietà, istituzioni dotalizie Salvucci, Zitelle povere di Castiglioni, Bernardino di Pietro di Piticchio.
L'Orfanotrofio, "che migliora la Scuola pia delle Fanciulle, rende possibile il ricovero gratuito di dieci fanciulle orfane povere, le quali oltre all'educazione morale riceveranno nelle pubbliche scuole l'istruzione elementare" e nell'istituto apprenderanno e si dedicheranno ai lavori femminili, soprattutto di sartoria, "facendosi diritto ad una dote in corredo e in denaro", di gran lunga superiore a quelle di istituzioni simili.
La Scuola di calzoleria, convertita in Borsa di studio per arti e mestieri,era destinata ad un giovane di "disagiata fortuna" per farlo istruire in qualche istituto nell'arte o mestiere al quale fosse più inclinato.
Questa proposta venne accolta con parere favorevole dalla Giunta provinciale amministrativa.
Il raggruppamento e i concentramenti riguardavano solo il funzionamento operativo e distributivo dell'istituto di beneficenza, mentre veniva salvaguardata l'autonomia patrimoniale ed amministrativa degli enti, in ottemperanza al principio della beneficenza italiana del "rispetto della volontà dei fondatori" e in dipendenza del carattere originario privatistico degli istituti di beneficenza, anche se mutato pubblicisticamente nel 1890 (la pubblicizzazione non andava intesa come statalizzazione delle opere pie, ma solo come aumento dei controlli pubblici).
Ad integrare la normativa del 1890, intervenne la legge giolittiana del 1904 n. 390, la quale sostituiva, per i controlli locali, le giunte provinciali di amministrazione, nominate da Crispi, con apposite commissioni provinciali di beneficenza e stabiliva la creazione del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.
Esistevano in Arcevia e suoi castelli diverse confraternite, di cui si trovano testimonianze documentarie nell'archivio della Congregazione di carità. Con regio decreto del 28 dicembre 1913, i patrimoni furono concentrati a favore dell'Ospedale e la Congregazione di carità acquisì, probabilmente, per fini amministrativi e contabili, documentazione delle seguenti confraternite: Santissimo Sacramento di Roccacontrada, la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, le Compagnie del Suffragio di San Giovanni Battista e del Santissimo Rosario di Montefortino, la Compagnia dello Spirito Santo di Sant'Appollinare, le Confraternite del Santissimo Sacramento, del Rosario e del Suffragio di Piticchio, la Confraternita del Santissimo Sacramento di Sant'Agata di Castiglioni, la Confraternita del Santissimo Rosario di Santo Stefano di Costa, la Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario di Colle Aprico, la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro in Musio.
La Confraternita del Santissimo Sacramento o del Corpo di Cristo esisteva dalla prima metà del 1500 nella chiesa di San Medardo. Verso la fine del 1500 si unì a quella del Crocifisso di S. Janne.
La prima notizia sulla Confaternita del Santissimo Sacramento di Piticchio risale al 1571 e riguardava un lascito testamentario; il 5 luglio 1575 la Confraternita riceveva la sanzione ufficiale della Chiesa, con la concessione dell'aggregazione all'Arciconfraternita di S. Maria sopra Minerva in Roma. Le rendite le provenivano dai lasciti privati e dalle chiese; suo obbligo era mantenere gli altari nella chiesa di San Sebastiano e amministrare l'Opera pia Bernardino di Pietro, che consisteva di tre legati. Il primo era per un cappellano con l'obbligo di celebrare quattro messe settimanali a suffragio dell'anima del testatore, il secondo per un'elemosina annua da dare ai poveri, il terzo per una dote annuale da assegnare a zitelle bisognose in funzione del matrimonio o della monacazione. La Confraternita disponeva di un proprio Monte frumentario di 25 rubbia di grano (circa 70 quintali) a servizio dei poveri, che venne liquidato nel 1770 per la costruzione della chiesa di San Sebastiano. Secondo lo statuto della fine del '700, la Confraternita era governata da due priori e disponeva di un direttore spirituale, del cancelliere addetto alla stesura dei verbali, del depositario incaricato della contabilità e del regolatore per le processioni. Inoltre eleggeva e stipendiava un maestro di cappella per San Sebastiano. Dopo il trasferimento delle sue rendite a favore dell'Ospedale di Arcevia, il Santissimo Sacramento di Piticchio sopravvisse con finalità prettamente religiose, sostenuto dal contributo della parrocchia e dalle pubbliche elemosine, almeno fino al 1944, anno in cui terminano i registri di contabilità .
La Confraternita del Rosario di Piticchio esisteva dal 1592 ed era stata istituita dopo la vittoria cristiana di Lepanto del 1571 per impulso papale. Aveva le stesse funzioni di quella del Santissimo Sacramento, manteneva il suo altare in San Sebastiano e disponeva di un Monte frumentario. Venne soppressa durante il periodo napoleonico e ricostituita nel 1830.
Poche notizie si hanno sulla Confraternita del Suffragio di Piticchio, avente funzione prevalentemente devozionale. Esisteva almeno dal 1669.
La prima notizia sulla Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro in Musio risale al 1815 e riguardava la registrazione catastale di una sua proprietà. Il 3 gennaio 1833 veniva istituita la "Pia unione del Cuore Purissimo di Maria Santissima della Madonna di Monte Vago" che aveva il compito di solennizzare la festa della Madonna la seconda domenica di novembre, di far celebrare l'officio per i soci defunti e quattro messe alla morte di ogni iscritto, di amministrare la chiesa di Montevago.
La Congregazione di carità acquistò la farmacia di proprietà del dr. Gisleno Mannucci (rogito del notaio dr. Costanzi Luigi del 2 agosto 1922, registrato in Arcevia il 26 agosto dello stesso anno). La farmacia assunse la denominazione di "Farmacia della Congregazione di Carità". Aveva per scopo la vendita dei medicinali al pubblico ed agli istituti dipendenti e non dipendenti, ai Comuni, enti morali, amministrazioni pubbliche che lo richiedevano. L'esercizio della farmacia costituiva una gestione speciale, tenuta in economia dalla Congregazione di carità (poi dall'ECA) e la cui contabilità finale era inserita in quella dell'Amministrazione centrale della Congregazione al tit. 3 del bilancio - Contabilità speciali.
La presidenza della Congregazione esercitava il controllo e la vigilanza generale su tutta l'azienda; a tale scopo poteva delegare un membro del Comitato dei Patroni. Gli uffici di segreteria e di ragioneria della Congregazione controllavano la contabilità e l'organizzazione tecnica-amministrativa e commerciale dell'azienda. Al principio della gestione veniva compilato un inventario generale dei beni mobili ed immobili costituenti il capitale fisso dell'azienda. Tale inventario doveva essere rinnovato ogni decennio. L'inventario compilato era poi comunicato ai singoli consegnatari dei beni e firmato per consegna. Ogni anno, entro il mese di gennaio, era redatto anche un esatto inventario di tutti i medicinali, oggetti, accessori non compresi nell'inventario generale. Gli inventari erano compilati dal personale della farmacia, a cura e sotto il controllo dell'ufficio di ragioneria dell'Amministrazione centrale della Congregazione.
Il bilancio di previsione della speciale azienda Farmacia entrava a far parte di quello della Congregazione di carità - Amministrazione centrale, al tit. 3 "Contabilità speciali". La contabilità speciale economico-patrimoniale e il collegamento con le scritture finanziarie generali venivano effettuati dall'ufficio di ragioneria della Congregazione. Il movimento giornaliero veviva desunto da un apposito giornale di cassa tenuto dalla farmacia e in cui dovevano essere annotate, cronologicamente e partita per partita, tutte le vendite e i movimenti di materiale avvenuti nel giorno, distinti quelli a contanti da quelli a crediti. Il direttore curava l'esatta e regolare tenuta del detto giornale di cassa e la conservazione delle ricette dei medicinali forniti a credito. Mensilmente doveva essere inviato alla presidenza della Congregazione un prospetto indicante sinteticamente il movimento commerciale della gestione speciale e lo stato di cassa.
Soppressa la Congregazione di carità, la farmacia, dopo essere stata amministrata dall'Ente comunale di assistenza, passò in piena proprietà agli Istituti riuniti di beneficenza con la denominazione e ditta commerciale di "Farmacia degli Istituti riuniti di beneficenza di Arcevia". Il regolamento rimase invariato.
Dopo la prima guerra mondiale, la caduta delle rendite degli istituti di beneficenza a causa dell'inflazione, l'aumento dei bisogni di assistenza di tutta la società italiana, fecero sì che il fascismo introducesse gli assegni familiari, allargasse le assicurazioni sociali ad altre categorie di cittadini, creasse nel 1925 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Con il regio decreto del 1923 n. 2841 vennero ridefinite le istituzioni pubbliche di beneficenza del 1890 in IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a sottolineare gli intenti di prevenzione assistenziale e di novità del regime.
Proponeva, poi, per l'Orfanotrofio femminile l'aggiunta ai beni appartenenti alla Scuola pia delle fanciulle delle rendite derivanti dalle Opere pie trasformate, cioè, Monte di Pietà, istituzioni dotalizie Salvucci, Zitelle povere di Castiglioni, Bernardino di Pietro di Piticchio.
L'Orfanotrofio, "che migliora la Scuola pia delle Fanciulle, rende possibile il ricovero gratuito di dieci fanciulle orfane povere, le quali oltre all'educazione morale riceveranno nelle pubbliche scuole l'istruzione elementare" e nell'istituto apprenderanno e si dedicheranno ai lavori femminili, soprattutto di sartoria, "facendosi diritto ad una dote in corredo e in denaro", di gran lunga superiore a quelle di istituzioni simili.
La Scuola di calzoleria, convertita in Borsa di studio per arti e mestieri,era destinata ad un giovane di "disagiata fortuna" per farlo istruire in qualche istituto nell'arte o mestiere al quale fosse più inclinato.
Questa proposta venne accolta con parere favorevole dalla Giunta provinciale amministrativa.
Il raggruppamento e i concentramenti riguardavano solo il funzionamento operativo e distributivo dell'istituto di beneficenza, mentre veniva salvaguardata l'autonomia patrimoniale ed amministrativa degli enti, in ottemperanza al principio della beneficenza italiana del "rispetto della volontà dei fondatori" e in dipendenza del carattere originario privatistico degli istituti di beneficenza, anche se mutato pubblicisticamente nel 1890 (la pubblicizzazione non andava intesa come statalizzazione delle opere pie, ma solo come aumento dei controlli pubblici).
Ad integrare la normativa del 1890, intervenne la legge giolittiana del 1904 n. 390, la quale sostituiva, per i controlli locali, le giunte provinciali di amministrazione, nominate da Crispi, con apposite commissioni provinciali di beneficenza e stabiliva la creazione del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.
Esistevano in Arcevia e suoi castelli diverse confraternite, di cui si trovano testimonianze documentarie nell'archivio della Congregazione di carità. Con regio decreto del 28 dicembre 1913, i patrimoni furono concentrati a favore dell'Ospedale e la Congregazione di carità acquisì, probabilmente, per fini amministrativi e contabili, documentazione delle seguenti confraternite: Santissimo Sacramento di Roccacontrada, la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, le Compagnie del Suffragio di San Giovanni Battista e del Santissimo Rosario di Montefortino, la Compagnia dello Spirito Santo di Sant'Appollinare, le Confraternite del Santissimo Sacramento, del Rosario e del Suffragio di Piticchio, la Confraternita del Santissimo Sacramento di Sant'Agata di Castiglioni, la Confraternita del Santissimo Rosario di Santo Stefano di Costa, la Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario di Colle Aprico, la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro in Musio.
La Confraternita del Santissimo Sacramento o del Corpo di Cristo esisteva dalla prima metà del 1500 nella chiesa di San Medardo. Verso la fine del 1500 si unì a quella del Crocifisso di S. Janne.
La prima notizia sulla Confaternita del Santissimo Sacramento di Piticchio risale al 1571 e riguardava un lascito testamentario; il 5 luglio 1575 la Confraternita riceveva la sanzione ufficiale della Chiesa, con la concessione dell'aggregazione all'Arciconfraternita di S. Maria sopra Minerva in Roma. Le rendite le provenivano dai lasciti privati e dalle chiese; suo obbligo era mantenere gli altari nella chiesa di San Sebastiano e amministrare l'Opera pia Bernardino di Pietro, che consisteva di tre legati. Il primo era per un cappellano con l'obbligo di celebrare quattro messe settimanali a suffragio dell'anima del testatore, il secondo per un'elemosina annua da dare ai poveri, il terzo per una dote annuale da assegnare a zitelle bisognose in funzione del matrimonio o della monacazione. La Confraternita disponeva di un proprio Monte frumentario di 25 rubbia di grano (circa 70 quintali) a servizio dei poveri, che venne liquidato nel 1770 per la costruzione della chiesa di San Sebastiano. Secondo lo statuto della fine del '700, la Confraternita era governata da due priori e disponeva di un direttore spirituale, del cancelliere addetto alla stesura dei verbali, del depositario incaricato della contabilità e del regolatore per le processioni. Inoltre eleggeva e stipendiava un maestro di cappella per San Sebastiano. Dopo il trasferimento delle sue rendite a favore dell'Ospedale di Arcevia, il Santissimo Sacramento di Piticchio sopravvisse con finalità prettamente religiose, sostenuto dal contributo della parrocchia e dalle pubbliche elemosine, almeno fino al 1944, anno in cui terminano i registri di contabilità .
La Confraternita del Rosario di Piticchio esisteva dal 1592 ed era stata istituita dopo la vittoria cristiana di Lepanto del 1571 per impulso papale. Aveva le stesse funzioni di quella del Santissimo Sacramento, manteneva il suo altare in San Sebastiano e disponeva di un Monte frumentario. Venne soppressa durante il periodo napoleonico e ricostituita nel 1830.
Poche notizie si hanno sulla Confraternita del Suffragio di Piticchio, avente funzione prevalentemente devozionale. Esisteva almeno dal 1669.
La prima notizia sulla Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro in Musio risale al 1815 e riguardava la registrazione catastale di una sua proprietà. Il 3 gennaio 1833 veniva istituita la "Pia unione del Cuore Purissimo di Maria Santissima della Madonna di Monte Vago" che aveva il compito di solennizzare la festa della Madonna la seconda domenica di novembre, di far celebrare l'officio per i soci defunti e quattro messe alla morte di ogni iscritto, di amministrare la chiesa di Montevago.
La Congregazione di carità acquistò la farmacia di proprietà del dr. Gisleno Mannucci (rogito del notaio dr. Costanzi Luigi del 2 agosto 1922, registrato in Arcevia il 26 agosto dello stesso anno). La farmacia assunse la denominazione di "Farmacia della Congregazione di Carità". Aveva per scopo la vendita dei medicinali al pubblico ed agli istituti dipendenti e non dipendenti, ai Comuni, enti morali, amministrazioni pubbliche che lo richiedevano. L'esercizio della farmacia costituiva una gestione speciale, tenuta in economia dalla Congregazione di carità (poi dall'ECA) e la cui contabilità finale era inserita in quella dell'Amministrazione centrale della Congregazione al tit. 3 del bilancio - Contabilità speciali.
La presidenza della Congregazione esercitava il controllo e la vigilanza generale su tutta l'azienda; a tale scopo poteva delegare un membro del Comitato dei Patroni. Gli uffici di segreteria e di ragioneria della Congregazione controllavano la contabilità e l'organizzazione tecnica-amministrativa e commerciale dell'azienda. Al principio della gestione veniva compilato un inventario generale dei beni mobili ed immobili costituenti il capitale fisso dell'azienda. Tale inventario doveva essere rinnovato ogni decennio. L'inventario compilato era poi comunicato ai singoli consegnatari dei beni e firmato per consegna. Ogni anno, entro il mese di gennaio, era redatto anche un esatto inventario di tutti i medicinali, oggetti, accessori non compresi nell'inventario generale. Gli inventari erano compilati dal personale della farmacia, a cura e sotto il controllo dell'ufficio di ragioneria dell'Amministrazione centrale della Congregazione.
Il bilancio di previsione della speciale azienda Farmacia entrava a far parte di quello della Congregazione di carità - Amministrazione centrale, al tit. 3 "Contabilità speciali". La contabilità speciale economico-patrimoniale e il collegamento con le scritture finanziarie generali venivano effettuati dall'ufficio di ragioneria della Congregazione. Il movimento giornaliero veviva desunto da un apposito giornale di cassa tenuto dalla farmacia e in cui dovevano essere annotate, cronologicamente e partita per partita, tutte le vendite e i movimenti di materiale avvenuti nel giorno, distinti quelli a contanti da quelli a crediti. Il direttore curava l'esatta e regolare tenuta del detto giornale di cassa e la conservazione delle ricette dei medicinali forniti a credito. Mensilmente doveva essere inviato alla presidenza della Congregazione un prospetto indicante sinteticamente il movimento commerciale della gestione speciale e lo stato di cassa.
Soppressa la Congregazione di carità, la farmacia, dopo essere stata amministrata dall'Ente comunale di assistenza, passò in piena proprietà agli Istituti riuniti di beneficenza con la denominazione e ditta commerciale di "Farmacia degli Istituti riuniti di beneficenza di Arcevia". Il regolamento rimase invariato.
Dopo la prima guerra mondiale, la caduta delle rendite degli istituti di beneficenza a causa dell'inflazione, l'aumento dei bisogni di assistenza di tutta la società italiana, fecero sì che il fascismo introducesse gli assegni familiari, allargasse le assicurazioni sociali ad altre categorie di cittadini, creasse nel 1925 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Con il regio decreto del 1923 n. 2841 vennero ridefinite le istituzioni pubbliche di beneficenza del 1890 in IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a sottolineare gli intenti di prevenzione assistenziale e di novità del regime.
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
ente di assistenza e beneficenza
Soggetti produttori:
Ente comunale di assistenza - ECA di Arcevia, successore
Ospedale Umberto I di Arcevia, collegato
Scuola pia delle fanciulle di Arcevia, collegato
Profili istituzionali collegati:
Congregazione di carità, 1862 - 1937
Complessi archivistici prodotti:
Congregazione di carità di Arcevia (fondo)
Bibliografia:
S. LEPRE, Archivi diversi conservati negli archivi comunali, in "Gli archivi storici comunali. Lezioni di Archivistica", Rivista Storica del Lazio, anno VI, 1998.
V. VILLANI, Piticchio. Castrum Peticli, Ostra Vetere 2001
V. VILLANI, San Pietro, Castrum Sancti Petri in Musio, Ostra Vetere 1999
Redazione e revisione:
Palma Maria, 2013, supervisione della scheda
Papi Tatiana, 2008/03/12, prima redazione
Papi Tatiana, 2013, revisione