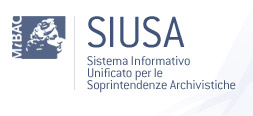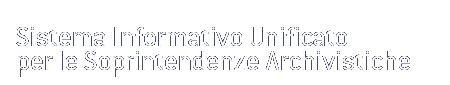Date di esistenza: sec. XIII -
Intestazioni:
Comune di Catania, Catania, sec. XIII -, SIUSA
Durante la dominazione normanna lo stretto legame tra Regno e Papato, mantenne ai vescovi il governo delle maggiori città tra cui la città di Catania, che aveva già conosciuto il governo ecclesiastico in epoca bizantina. Con gli Hohenstaufen (1197) Catania divenne città demaniale e rispondeva al sovrano tramite i baiuli. Nel 1232, gli Svevi concessero a due cittadini, eletti dal popolo, di formare insieme al baiulo un corpo amministrativo con limitata potestà giudiziaria. I designati mantennero l'appellativo di jurati sino alla riforma borbonica del 1817. I nobili non furono eleggibili sin quando re Martino non istituì il privilegio del "bussolo", attraverso il quale gli stessi riuscirono ad occupare ogni carica pubblica. Gli angioini ed gli aragonesi confermarono a Catania i privilegi e le consuetudini via via concessi, avallati da re Martino d'Aragona con i Capitoli del 1392.
Agli inizi del 1300, la Corte patriziale era composta dal Patrizio, da un giureperito e da un notaio-cancelliere, cui si aggiunsero un giudice popolano (judichi ideota) e uno borghese (judichi onorato).
Le attribuzioni di tale Corte erano simili a quelle degli odierni assessori, con la prerogativa, inoltre, di punire i contravventori ed assistere ai Reali Consigli. Il Consesso, con privilegio reale del 1624, venne denominato Senato presieduto da un Procuratore generale detto sin dal 1507 Sindaco.
La dipendenza dal Vicereame di Spagna sancì de jure la supremazia della nobiltà locale sulla città regia di Catania; nel 1572 fu decretato che i Giurati fossero tratti esclusivamente dalla cosidetta "Mastra Nobile" o "Mastra Serrata". Nel 1577 si stabilì che lo scrutinio avvenisse pubblicamente in un solo giorno; così venivano anche eletti i funzionari tra cui: i Capi di Xiurta, ufficiali che vigilavano alla sicurezza; gli Statuti che sorvegliavano la qualità delle derrate vendute; gli Acatapani, istituiti da Federico II d'Aragona con funzioni annonarie; il Sindaco; i Reformatori dello Studio (Università); gli Acatapani Nobili; gli Ufficiali della milizia di Aci etc.
Per gli affari urgenti si indiceva il Gran Consiglio, generale o ordinario, cui prendevano parte, oltre ai magistrati municipali, il Capitano giustiziere, i magistrati giudiziari e tutte le altre autorità, i militi, i capi delle maestranze (corporazioni), i mercanti, i capi famiglia e, nei consigli straordinari, anche il popolo.
Nel 1675, dopo la rivolta di Catania del 1647-48 e quella di Messina del 1674-78, il Viceré, per pacificare le opposte fazioni, abolì il Bussolo; dalla Mastra nobile venivano comunque scelti i magistrati di nomina regia.
I Giurati si riunivano nella Loggia, in seguito divenuta Palazzo Senatorio, e le loro decisioni erano raccolte negli Atti dei Giurati, poi denominati Atti del Senato, infine Atti del Decurionato (1820-1860).
Tra il 1500 ed il 1600 sotto il dominio spagnolo, a Catania vennero concessi titoli, privilegi ed autonomie privi di valore sostanziale. Emanuele Filiberto di Savoia, viceré di Sicilia, con lettera ratificata nel 1622 da Filippo IV, assegnò al Senato catanese funzioni pari a quelli di Palermo e Messina; lo stesso vicerè curò, altresì, che i giudici della Curia catanese fossero iscritti alla Mastra nobile.
Gli antesignani dell'attuale assetto degli enti territoriali siciliani sono da rinvenire nella legislazione varata da Ferdinando di Borbone tra il 1816 ed il 1818. Catania, che sino a quel momento deteneva l'appellativo di Urbs (Città), verrà denominata Comune. Con Regio Decreto n. 932 del 1817, la suddivisione amministrativa già in vigore negli altri territori del Regno delle Due Sicilia detti domini al di quà del faro, venne estesa anche alla Sicilia. Il nuovo modello amministrativo introdotto, ispirato al modello francese verticalmente accentrato, cancellò definitivamente l'ordinamento feudale: gli storici Valli (Mazara, Noto, Demone) furono soppressi ed articolati in sette Intendenze o "Valli Minori" - Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta - cui vennero attribuite i distretti già esistenti. L'Intendente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Consiglio di Intendenza (giudice del contenzioso amministrativo), rappresentava il Governo provinciale. Egli presiedeva tutti i rami dell' amministrazione civile ed era l'immediato tutore dei comuni. Inoltre, nell'ambito delle province furono istituiti apparati di intermediazione tra il potere centrale e quello locale, quali ad esempio le Sottointendenze, i Consigli provinciali e i Consigli distrettuali. I comuni, sottoposti a rigidi controlli, sostituirono il vecchio Consiglio civico con un Decurionato, organo deliberativo più agile che a Catania, così come a Palermo e a Messina, era di nomina regia.
Il potere esecutivo divenne appannaggio del Sindaco che, designato dal Decurionato, mantenne il titolo di Patrizio. Gli si affiancarono il primo eletto, responsabile della Polizia Amministrativa, il secondo eletto Vicario del Sindaco e due deputati scelti annualmente dal Decurionato nei suoi stessi ranghi. Alla gestione finanziaria fu preposto un cassiere, e furono previste particolari Deputazioni e Commissioni. Accanto a questo personale di natura politica, selezionato in base al censo, vi era il Cancelliere archivario, impiegato amministrativo, cui venivano affidati l'uffizio, l'archivio ed il suggello del comune. Egli rappresentava, rispetto all'avvicendarsi degli altri amministratori, la continuità dell'apparato.
Il provvisorio Governo Dittatoriale del 1860 sostituì gli Intendenti con i Governatori dei Distretti e i Decurionati con i Consigli Civici. La successiva introduzione dell'ordinamento provinciale piemontese del 1859 avviò la Sicilia alle progressive fasi di annessione al Regno d'Italia. Dopo l'Unità, l'articolazione di Comuni e Province venne disciplinata dall'allegato A del T.U. n. 2248 del 1865 (legge Rattazzi), cui seguirono: la L. n. 5921 del 1889 (elezione del Sindaco nei comuni maggiori ed istituzione della Giunta provinciale amministrativa), la L. n.164 del 1898 (elezione generalizzata del Sindaco), la L. n. 269 del 1908 (stato giuridico del Segretario comunale e degli impiegati, gestione finanziaria) e la L. n. 148 del 1915 (elettorato, sovrimposte).
Dal 1922 al 1926, con l'avvento del regime fascista, Catania fu retta da Commissari prefettizi. Il Sindaco, per effetto della L. n. 237 del 1926, venne definitivamente sostituito da un Podestà governativo che, sotto il controllo prefettizio, cumulava le funzioni di Giunta e Consiglio, affiancato dalla Consulta municipale.
Nel 1944 al Commissario prefettizio succedette, per nomina alleata, il primo Sindaco eletto dal 1922.
Dopo la guerra, la L. n. 1058 ed il T.U. n. 203 del 1947, ripristinarono il sistema elettorale cancellato dal fascismo. Alla Sicilia, scossa da fermenti separatisti, fu riconosciuta larga autonomia con il nuovo Statuto (RDL n. 455 del 1946), ratificato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1948. Nell'ambito delle prerogative garantite anche dall'art.116 della Costituzione si è formato l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; il vigente assetto degli enti locali è, altresì, da rinvenirsi nella legge n° 142 del 1990 e nella Legge Regionale n. 7 del 1992 inerente, tra l'altro, l'elezione diretta del Sindaco.
La dipendenza dal Vicereame di Spagna sancì de jure la supremazia della nobiltà locale sulla città regia di Catania; nel 1572 fu decretato che i Giurati fossero tratti esclusivamente dalla cosidetta "Mastra Nobile" o "Mastra Serrata". Nel 1577 si stabilì che lo scrutinio avvenisse pubblicamente in un solo giorno; così venivano anche eletti i funzionari tra cui: i Capi di Xiurta, ufficiali che vigilavano alla sicurezza; gli Statuti che sorvegliavano la qualità delle derrate vendute; gli Acatapani, istituiti da Federico II d'Aragona con funzioni annonarie; il Sindaco; i Reformatori dello Studio (Università); gli Acatapani Nobili; gli Ufficiali della milizia di Aci etc.
Per gli affari urgenti si indiceva il Gran Consiglio, generale o ordinario, cui prendevano parte, oltre ai magistrati municipali, il Capitano giustiziere, i magistrati giudiziari e tutte le altre autorità, i militi, i capi delle maestranze (corporazioni), i mercanti, i capi famiglia e, nei consigli straordinari, anche il popolo.
Nel 1675, dopo la rivolta di Catania del 1647-48 e quella di Messina del 1674-78, il Viceré, per pacificare le opposte fazioni, abolì il Bussolo; dalla Mastra nobile venivano comunque scelti i magistrati di nomina regia.
I Giurati si riunivano nella Loggia, in seguito divenuta Palazzo Senatorio, e le loro decisioni erano raccolte negli Atti dei Giurati, poi denominati Atti del Senato, infine Atti del Decurionato (1820-1860).
Tra il 1500 ed il 1600 sotto il dominio spagnolo, a Catania vennero concessi titoli, privilegi ed autonomie privi di valore sostanziale. Emanuele Filiberto di Savoia, viceré di Sicilia, con lettera ratificata nel 1622 da Filippo IV, assegnò al Senato catanese funzioni pari a quelli di Palermo e Messina; lo stesso vicerè curò, altresì, che i giudici della Curia catanese fossero iscritti alla Mastra nobile.
Gli antesignani dell'attuale assetto degli enti territoriali siciliani sono da rinvenire nella legislazione varata da Ferdinando di Borbone tra il 1816 ed il 1818. Catania, che sino a quel momento deteneva l'appellativo di Urbs (Città), verrà denominata Comune. Con Regio Decreto n. 932 del 1817, la suddivisione amministrativa già in vigore negli altri territori del Regno delle Due Sicilia detti domini al di quà del faro, venne estesa anche alla Sicilia. Il nuovo modello amministrativo introdotto, ispirato al modello francese verticalmente accentrato, cancellò definitivamente l'ordinamento feudale: gli storici Valli (Mazara, Noto, Demone) furono soppressi ed articolati in sette Intendenze o "Valli Minori" - Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta - cui vennero attribuite i distretti già esistenti. L'Intendente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Consiglio di Intendenza (giudice del contenzioso amministrativo), rappresentava il Governo provinciale. Egli presiedeva tutti i rami dell' amministrazione civile ed era l'immediato tutore dei comuni. Inoltre, nell'ambito delle province furono istituiti apparati di intermediazione tra il potere centrale e quello locale, quali ad esempio le Sottointendenze, i Consigli provinciali e i Consigli distrettuali. I comuni, sottoposti a rigidi controlli, sostituirono il vecchio Consiglio civico con un Decurionato, organo deliberativo più agile che a Catania, così come a Palermo e a Messina, era di nomina regia.
Il potere esecutivo divenne appannaggio del Sindaco che, designato dal Decurionato, mantenne il titolo di Patrizio. Gli si affiancarono il primo eletto, responsabile della Polizia Amministrativa, il secondo eletto Vicario del Sindaco e due deputati scelti annualmente dal Decurionato nei suoi stessi ranghi. Alla gestione finanziaria fu preposto un cassiere, e furono previste particolari Deputazioni e Commissioni. Accanto a questo personale di natura politica, selezionato in base al censo, vi era il Cancelliere archivario, impiegato amministrativo, cui venivano affidati l'uffizio, l'archivio ed il suggello del comune. Egli rappresentava, rispetto all'avvicendarsi degli altri amministratori, la continuità dell'apparato.
Il provvisorio Governo Dittatoriale del 1860 sostituì gli Intendenti con i Governatori dei Distretti e i Decurionati con i Consigli Civici. La successiva introduzione dell'ordinamento provinciale piemontese del 1859 avviò la Sicilia alle progressive fasi di annessione al Regno d'Italia. Dopo l'Unità, l'articolazione di Comuni e Province venne disciplinata dall'allegato A del T.U. n. 2248 del 1865 (legge Rattazzi), cui seguirono: la L. n. 5921 del 1889 (elezione del Sindaco nei comuni maggiori ed istituzione della Giunta provinciale amministrativa), la L. n.164 del 1898 (elezione generalizzata del Sindaco), la L. n. 269 del 1908 (stato giuridico del Segretario comunale e degli impiegati, gestione finanziaria) e la L. n. 148 del 1915 (elettorato, sovrimposte).
Dal 1922 al 1926, con l'avvento del regime fascista, Catania fu retta da Commissari prefettizi. Il Sindaco, per effetto della L. n. 237 del 1926, venne definitivamente sostituito da un Podestà governativo che, sotto il controllo prefettizio, cumulava le funzioni di Giunta e Consiglio, affiancato dalla Consulta municipale.
Nel 1944 al Commissario prefettizio succedette, per nomina alleata, il primo Sindaco eletto dal 1922.
Dopo la guerra, la L. n. 1058 ed il T.U. n. 203 del 1947, ripristinarono il sistema elettorale cancellato dal fascismo. Alla Sicilia, scossa da fermenti separatisti, fu riconosciuta larga autonomia con il nuovo Statuto (RDL n. 455 del 1946), ratificato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1948. Nell'ambito delle prerogative garantite anche dall'art.116 della Costituzione si è formato l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; il vigente assetto degli enti locali è, altresì, da rinvenirsi nella legge n° 142 del 1990 e nella Legge Regionale n. 7 del 1992 inerente, tra l'altro, l'elezione diretta del Sindaco.
Condizione giuridica:
pubblico (sec. XIII - )
Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale (sec. XIII - )
Profili istituzionali collegati:
Comune (Regno delle due Sicilie), 1816 - 1860
Comune, 1859 -
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Catania (fondo)
Stato civile del Comune di Catania (fondo)
Bibliografia:
FINOCCHIARO V.,Storia dell'ordinamento degli Achivi pubblici di Catania, vol. II, ed. Giannotta, Catania 1907
G. CALABRESE, Intendenze borboniche e archivi comunali in Sicilia, in "Rassegna degli Archivi", n. 1, LV, Roma 1995
AA. VV., Il riscatto della Memoria. Materiali per la ricostruzione dell'Archivio Storico della città di Catania. Redazione a cura di MARCELLA MINISSALE e TINO VITTORIO, ed. Maimone, Catania 1998
DI MARIA V., La Sicilia e la storia, vol II, ed. Tringale, 1989 Catania
G. DI NUOVO, Amministrazione comunale, in Enciclopedia di Catania. Diretta da VITTORIO CONSOLI, vol. I, ed Tringale, Catania 1986
Redazione e revisione:
Minissale Marcella, 2006, raccolta delle informazioni
Montagno Elena - direzione lavori Romano, 2007, rielaborazione