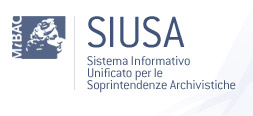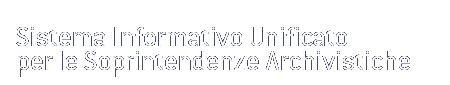Intestazioni:
Salvagnoli, Antonio, (Corniola di Empoli 1810 - Firenze 1888), SIUSA
Ultimogenito di Cosimo Ignazio e di Silvia Genovesi, Antonio Salvagnoli, dopo gli studi secondari, studiò medicina all'Università di Pisa dove si laureò nel 1830. Presso la Scuola annessa all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova ottenne poi l'abilitazione ad esercitare la professione. Dopo la laurea esercitò per alcuni anni l'attività di medico condotto dapprima a Santa Croce sull'Arno, quindi presso una delle condotte mediche di Vinci con residenza in Empoli, e nel 1835 ottenne la condotta medica di Empoli. Nel marzo del 1839 si trasferì a Firenze per esercitare la professione, ma fu subito inviato nelle maremme toscane dove infieriva una epidemia di mal'aria e nominato medico ispettore della provincia di Grosseto, nella neonata Commissione sanitaria (1940). Da questa esperienza, durata fino al marzo 1849, Antonio trasse materia per il suo Saggio relativo alle tavole della statistica medica delle Maremme Toscane del 1844 e per altri studi medico-statistici. Il lungo soggiorno in Maremma, oltre a quello per gli aspetti igienico-sanitari, determinò anche il suo interesse per i problemi economici e sociali della zona, che lo portò ad allargare l'orizzonte dei suoi studi a molti altri aspetti: dall'agricoltura, all'industria estrattiva, alle tecniche di bonifica e perfino all'erudizione storica. Nel febbraio 1847, fu uno dei soci fondatori dell'Associazione agraria della provincia grossetana. Il compito di stendere il Rapporto generale statistico agrario della provincia di Grosseto commissionato dall'associazione fu steso dal segretario Salvagnoli e da lui consegnato al presidente già nel settembre 1849, ma alcune sue proposte furono criticate da parte di alcuni proprietari. Egli chiese allora di essere allontanato dall'incarico di ispettore sanitario e si dimise da segretario della Associazione.
Nel marzo 1840, Salvagnoli aveva ottenuto la nomina a socio corrispondente della Accademia dei Georgofili e la sua prima lettura, del 7 febbraio 1841 ebbe per tema le Considerazioni agrarie sulle maremme. Dopo essere diventato socio ordinario dell'Accademia il 21 gennaio 1844, egli ne assunse anche la segreteria: nel periodo agosto-settembre 1851 e nel luglio e poi continuativamente dal 1854 al 1857, qui fu in stretti rapporti con Cosimo Ridolfi che affiancò in diverse occasioni. Fra gli altri incarichi, fu membro della Accademia medico-chirurgica di Torino (1846) e di quella di Ferrara (1847). Compì diversi viaggi negli Stati Sardi e nel Lombardo-Veneto, soprattutto per partecipare ai periodici congressi degli scienziati e fece parte di vari comitati per organizzare la partecipazione della Toscana prima, e dell'Italia poi, alle esposizioni nazionali e universali.
Nel 1859, con l'istituzione, dopo la partenza del granduca, di un governo provvisorio presieduto dall'amico Bettino Ricasoli e nel quale il fratello Vincenzo entrò come ministro degli affari ecclesiastici, Antonio trovò una collocazione consona alle sue competenze tecniche. Infatti uno dei primi provvedimenti del nuovo governo fu l'istituzione di una Commissione sul bonificamento delle maremme con il compito di riprendere in mano l'annoso problema, su basi completamente diverse da quelle del soppresso Ufficio granducale. Nel nuovo stato italiano, il Salvagnoli continuò ad assumere incarichi istituzionali su questi problemi: divenne membro della commissione istituita con R. D. del 13 gennaio 1861 con il compito di riferire al Ministro dei Lavori pubblici il fatto e il da farsi nelle maremme sarde e toscane per bonificarle.
Nell'ultimo periodo della vita, Antonio si dedicò ad un progetto per la bonifica dell'agro romano, e come era nelle sue consuetudini, la stesura del progetto fu preceduta dalla raccolta materiale storico sulla questione. Fin dal 1870 era stato nominato membro della commissione creata dal ministro dei lavori pubblici "sulle condizioni in cui si trova l'Amministrazione delle bonifiche", presieduta dal senatore Giuseppe Devincenzi; rimase a farne parte fino al 1876, quando la commissione, all'epoca formata da Salvagnoli, Vitelleschi, Rosa, Cannizzaro e Torelli, elaborò il progetto per la bonifica dell'Agro Romano.
Per quanto riguarda la carriera politica, Antonio in piena sintonia col fratello Vincenzo professò per tutta la vita idee liberali e guardò con simpatia al moto risorgimentale, anche se la sua qualità di pubblico dipendente gli impedì di prendere posizioni di aperta critica al governo granducale. Nel 1860 quando Vincenzo fu nominato senatore, Antonio gli subentrò come deputato al Parlamento nazionale per la circoscrizione di Empoli. Questo mandato gli fu rinnovato per altre quattro legislature (dall'VIII alla XI); nel novembre del 1874 fu a sua volta nominato senatore. La sua azione parlamentare si esplicò soprattutto nei provvedimenti che riguardavano la sanità pubblica, l'agricoltura, i lavori pubblici, la caccia e la pesca. Sul piano locale, Antonio fu per varie legislature consigliere comunale di Empoli (dal 1856 al 1877); in questo ambito fece parte di commissioni e comitati per studiare specifici problemi: ad esempio della "Congregazione per vigilare sull'amministrazione di opere pie". Fu tra i promotori della fondazione tanto dell'Istituto agrario di Castelletti (Signa) che dell'Istituto di Arti e Manifatture di Firenze, di cui fu anche docente. Fu socio effettivo od onorario di vari sodalizi, dalla Società di Mutuo Soccorso tra gli operai di Empoli alla Società Musicale di Santa Cecilia.
Ottenne onorificenze da parte dei Savoia che gli riconobbero il titolo di nobile nel 1863; entrò con il titolo di cavaliere, conferitogli nel 1860, nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che percorse fino al grado di ufficiale nel febbraio 1878, così come percorse tutti i gradi dell'Ordine della Corona d'Italia, da quello di cavaliere (settembre 1868) a quello di Commendatore (maggio 1877). Nel 1877, per il deteriorarsi delle sue condizioni di salute, dette le dimissioni dalla maggior parte dei suoi incarichi e dedicò l'ultimo periodo della sua vita a promuovere la pubblicazione degli scritti del fratello Vincenzo. Ma egli morì senza aver visto la realizzazione dell'impresa che, senza il suo impulso ed il suo sostegno, naufragò in breve tempo.
Nel 1859, con l'istituzione, dopo la partenza del granduca, di un governo provvisorio presieduto dall'amico Bettino Ricasoli e nel quale il fratello Vincenzo entrò come ministro degli affari ecclesiastici, Antonio trovò una collocazione consona alle sue competenze tecniche. Infatti uno dei primi provvedimenti del nuovo governo fu l'istituzione di una Commissione sul bonificamento delle maremme con il compito di riprendere in mano l'annoso problema, su basi completamente diverse da quelle del soppresso Ufficio granducale. Nel nuovo stato italiano, il Salvagnoli continuò ad assumere incarichi istituzionali su questi problemi: divenne membro della commissione istituita con R. D. del 13 gennaio 1861 con il compito di riferire al Ministro dei Lavori pubblici il fatto e il da farsi nelle maremme sarde e toscane per bonificarle.
Nell'ultimo periodo della vita, Antonio si dedicò ad un progetto per la bonifica dell'agro romano, e come era nelle sue consuetudini, la stesura del progetto fu preceduta dalla raccolta materiale storico sulla questione. Fin dal 1870 era stato nominato membro della commissione creata dal ministro dei lavori pubblici "sulle condizioni in cui si trova l'Amministrazione delle bonifiche", presieduta dal senatore Giuseppe Devincenzi; rimase a farne parte fino al 1876, quando la commissione, all'epoca formata da Salvagnoli, Vitelleschi, Rosa, Cannizzaro e Torelli, elaborò il progetto per la bonifica dell'Agro Romano.
Per quanto riguarda la carriera politica, Antonio in piena sintonia col fratello Vincenzo professò per tutta la vita idee liberali e guardò con simpatia al moto risorgimentale, anche se la sua qualità di pubblico dipendente gli impedì di prendere posizioni di aperta critica al governo granducale. Nel 1860 quando Vincenzo fu nominato senatore, Antonio gli subentrò come deputato al Parlamento nazionale per la circoscrizione di Empoli. Questo mandato gli fu rinnovato per altre quattro legislature (dall'VIII alla XI); nel novembre del 1874 fu a sua volta nominato senatore. La sua azione parlamentare si esplicò soprattutto nei provvedimenti che riguardavano la sanità pubblica, l'agricoltura, i lavori pubblici, la caccia e la pesca. Sul piano locale, Antonio fu per varie legislature consigliere comunale di Empoli (dal 1856 al 1877); in questo ambito fece parte di commissioni e comitati per studiare specifici problemi: ad esempio della "Congregazione per vigilare sull'amministrazione di opere pie". Fu tra i promotori della fondazione tanto dell'Istituto agrario di Castelletti (Signa) che dell'Istituto di Arti e Manifatture di Firenze, di cui fu anche docente. Fu socio effettivo od onorario di vari sodalizi, dalla Società di Mutuo Soccorso tra gli operai di Empoli alla Società Musicale di Santa Cecilia.
Ottenne onorificenze da parte dei Savoia che gli riconobbero il titolo di nobile nel 1863; entrò con il titolo di cavaliere, conferitogli nel 1860, nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che percorse fino al grado di ufficiale nel febbraio 1878, così come percorse tutti i gradi dell'Ordine della Corona d'Italia, da quello di cavaliere (settembre 1868) a quello di Commendatore (maggio 1877). Nel 1877, per il deteriorarsi delle sue condizioni di salute, dette le dimissioni dalla maggior parte dei suoi incarichi e dedicò l'ultimo periodo della sua vita a promuovere la pubblicazione degli scritti del fratello Vincenzo. Ma egli morì senza aver visto la realizzazione dell'impresa che, senza il suo impulso ed il suo sostegno, naufragò in breve tempo.
Complessi archivistici prodotti:
Salvagnoli Marchetti, famiglia (fondo)
Bibliografia:
ARRIGHI V. - GUERRINI L. - INSABATO E. - TERRENI S., Inventario dell'archivio Salvagnoli Marchetti, Pisa, Pacini, 2002, pp. 294, 187-195 (S. Terreni)
Redazione e revisione:
Romanelli Rita, 2009/06/13, prima redazione