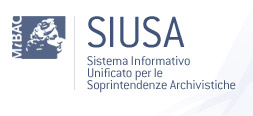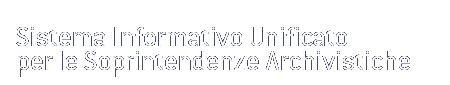sec. XVII -
nobiluomini dal sec. XIX
Intestazioni:
Piersanti, Matelica (Macerata), sec. XVII -, SIUSA
Le prime attestazioni documentarie e storiche sulla famiglia Piersanti risalgono al XVII secolo. Piccoli possidenti terrieri probabilmente attivi nella produzione o nel commercio dei panni lana, i Piersanti solo agli inizi del secolo successivo si affermarono sulla scena matelicese ed entrarono a far parte del patriziato locale.
Il loro esponente più illustre fu senza dubbio Venanzio Filippo Piersanti (1688-1761), primogenito dei nove figli nati dall'unione di Francesco Maria con Faustina Orsi, il quale venne avviato ad intraprendere la carriera ecclesiastica sulle orme dello zio Antonio, abate domenicano. Dopo gli studi presso il seminario di Nocera Umbra, il giovane Venanzio Filippo si trasferì a Roma, dove completò la formazione. Le particolari doti e una spiccata personalità favorirono la sua rapida ascesa: all'età di diciannove anni fu ordinato sacerdote da papa Clemente XI Albani, che a sua volta nel 1718 lo nominò sesto Maestro di cerimonia della Cappella pontificia e suo "familiare e commensale". Tali incarichi furono confermati negli anni successivi e altri ancora gli saranno assegnati (cappellano segreto, primo Maestro delle cerimonie, beneficiario della Basilica Vaticana e Canonico della Basilica dei Santi Apostoli) da Innocenzo XIII, Benedetto XIII, Clemente XII, Benedetto XIV fino a Clemente XIII, divenendo per oltre quarant'anni un insigne prelato al servizio dei pontefici. I proventi e i privilegi connessi alla prestigiosa posizione raggiunta alla corte papale da Venanzio Filippo Piersanti, ai quali si devono aggiungere quelli derivati dalla sua attività di agente in Roma per conto della comunità matelicese, determinarono l'accumulo di un considerevole patrimonio che valse a sé e alla famiglia, nonché alle generazioni seguenti, benessere e ricchezza.
Morì a Roma il 23 aprile 1761 all'età di settantatre anni, e le sue spoglie furono sepolte, secondo alcune fonti, all'interno della Sacrestia dei Canonici nella Basilica Vaticana.
Mentre la vita del monsignore si svolse prevalentemente a Roma (dove risiedeva insieme alla sorella Angela Giocondina nell'appartamento in Piazza Scossacavalli), a Matelica fu il fratello Giovanni (1702-1782) a rappresentare con lustro la famiglia. Compiuti gli studi a Roma, egli fece ritorno in patria dove si distinse nella vita culturale e politica della città: membro della nota Accademia dell'Arcadia con il nome di Argante, Giovanni Piersanti, oltre ad essere nominato Governatore delle Pie unioni di San Biagio e di San Giovanni e a svolgere la funzione di agente per alcune famiglie nobili del luogo, ricoprì anche la prestigiosa carica di gonfaloniere. A lui, inoltre, spettò il compito di continuare la discendenza, a causa della morte prematura degli altri fratelli. Dal tardivo matrimonio con Niccola Luzioli di Montefilottrano, celebrato nel 1750, nacque in effetti una numerosa progenie, composta però da ben otto femmine e da un solo maschio, Francesco Maria. Designato a proseguire l'ascesa sociale e politica della famiglia Piersanti, come testimoniano gli studi in collegio e la presenza nel Pubblico consiglio al posto del padre, quest'ultimo non ebbe la possibilità di rispondere a tali aspettative: la salute cagionevole e poi la prematura morte (sopraggiunta all'età di venticinque anni) segnarono immancabilmente il suo destino e quello della casata, che dopo di lui non ebbe più discendenti diretti. Lo stesso Francesco Maria cercò di evitare l'estinzione del nome e la dispersione del patrimonio di famiglia: nel suo testamento designò quale erede universale la sorella maggiore Faustina con l'obbligo di sposarsi e di trasmettere sia il nome, sia i beni stabili - includenti la casa paterna con tutti gli arredi - al suo primogenito e ai suoi eredi; qualora la designata non avesse avuto figli maschi, tale istituto di primogenitura e l'annesso fedecommesso dovevano continuare, in ordine di età, nella sorella che per prima avesse garantito un erede maschio.
Seppur celebrato nel 1783 con il nobile osimano Gioacchino Bellini, dal matrimonio di Faustina Piersanti non nacquero figli, tanto che erede testamentario divenne uno dei suoi nipoti, Francesco Tesei.
L'ultimo capitolo sulla storia della famiglia matelicese si concluse con il XIX secolo.
In seguito all'unione con la nobildonna Marianna Languidara di Serra de' Conti, Francesco ebbe un unico figlio, Filippo, il quale decise di rinunciare al cognome paterno per assumere quello dei Piersanti. Insignito del titolo di marchese dai Reali di Savoia, Filippo Piersanti (1818-1885) divenne nella Matelica del tempo un personaggio pubblico di primo piano: avvocato e ufficiale dell'ordine Mauriziano, egli si dedicò con attenzione all'amministrazione della città dapprima come membro del Consiglio poi nelle vesti di gonfaloniere e, dopo l'unità d'Italia, di sindaco. Con lui si estinse definitivamente la stirpe dei Piersanti di Matelica, visto che non ebbe nessun discendente dal matrimonio contratto con la contessa Teresa Capeci (sua cugina di secondo grado): entrambi riposano nel cimitero monumentale della città, ad esclusione degli altri esponenti della famiglia Piersanti che trovarono sepoltura all'interno della loro cappella istituita nella chiesa di San Filippo a Matelica (Sabina Biocco)
Mentre la vita del monsignore si svolse prevalentemente a Roma (dove risiedeva insieme alla sorella Angela Giocondina nell'appartamento in Piazza Scossacavalli), a Matelica fu il fratello Giovanni (1702-1782) a rappresentare con lustro la famiglia. Compiuti gli studi a Roma, egli fece ritorno in patria dove si distinse nella vita culturale e politica della città: membro della nota Accademia dell'Arcadia con il nome di Argante, Giovanni Piersanti, oltre ad essere nominato Governatore delle Pie unioni di San Biagio e di San Giovanni e a svolgere la funzione di agente per alcune famiglie nobili del luogo, ricoprì anche la prestigiosa carica di gonfaloniere. A lui, inoltre, spettò il compito di continuare la discendenza, a causa della morte prematura degli altri fratelli. Dal tardivo matrimonio con Niccola Luzioli di Montefilottrano, celebrato nel 1750, nacque in effetti una numerosa progenie, composta però da ben otto femmine e da un solo maschio, Francesco Maria. Designato a proseguire l'ascesa sociale e politica della famiglia Piersanti, come testimoniano gli studi in collegio e la presenza nel Pubblico consiglio al posto del padre, quest'ultimo non ebbe la possibilità di rispondere a tali aspettative: la salute cagionevole e poi la prematura morte (sopraggiunta all'età di venticinque anni) segnarono immancabilmente il suo destino e quello della casata, che dopo di lui non ebbe più discendenti diretti. Lo stesso Francesco Maria cercò di evitare l'estinzione del nome e la dispersione del patrimonio di famiglia: nel suo testamento designò quale erede universale la sorella maggiore Faustina con l'obbligo di sposarsi e di trasmettere sia il nome, sia i beni stabili - includenti la casa paterna con tutti gli arredi - al suo primogenito e ai suoi eredi; qualora la designata non avesse avuto figli maschi, tale istituto di primogenitura e l'annesso fedecommesso dovevano continuare, in ordine di età, nella sorella che per prima avesse garantito un erede maschio.
Seppur celebrato nel 1783 con il nobile osimano Gioacchino Bellini, dal matrimonio di Faustina Piersanti non nacquero figli, tanto che erede testamentario divenne uno dei suoi nipoti, Francesco Tesei.
L'ultimo capitolo sulla storia della famiglia matelicese si concluse con il XIX secolo.
In seguito all'unione con la nobildonna Marianna Languidara di Serra de' Conti, Francesco ebbe un unico figlio, Filippo, il quale decise di rinunciare al cognome paterno per assumere quello dei Piersanti. Insignito del titolo di marchese dai Reali di Savoia, Filippo Piersanti (1818-1885) divenne nella Matelica del tempo un personaggio pubblico di primo piano: avvocato e ufficiale dell'ordine Mauriziano, egli si dedicò con attenzione all'amministrazione della città dapprima come membro del Consiglio poi nelle vesti di gonfaloniere e, dopo l'unità d'Italia, di sindaco. Con lui si estinse definitivamente la stirpe dei Piersanti di Matelica, visto che non ebbe nessun discendente dal matrimonio contratto con la contessa Teresa Capeci (sua cugina di secondo grado): entrambi riposano nel cimitero monumentale della città, ad esclusione degli altri esponenti della famiglia Piersanti che trovarono sepoltura all'interno della loro cappella istituita nella chiesa di San Filippo a Matelica (Sabina Biocco)
Complessi archivistici prodotti:
Piersanti, famiglia (fondo)
Bibliografia:
A. ANTONELLI, Museo Piersanti, Bologna, Calderini, 1998
Guida al Museo Piersanti, Matelica, presentazione di Pietro Zampetti; testi di Mariolina Cegna e Milena Rotili, APT, Fabriano
P. ALLEGRINI, Guida di Matelica: storia, arte, turismo, Matelica, 1987
Redazione e revisione:
Palma Maria, 2015/04/20, supervisione della scheda
Papi Tatiana, 2015/04/20, revisione
Zega Valentina, 2009/02/10, prima redazione